Michele Cavallo & Gioia Ottaviani
C’è un sottile filo rosso che a partire da Artaud passa in Grotowski e in Carmelo Bene. Esperienze pur così distanti nei presupposti e negli esiti, vengono qui proposte per suggerire la collocazione del problema delle emozioni e del sentire performativo, nel superamento di “falsi problemi” in cui spesso ci si è attardati. Sulle orme di questi tre diversi cammini, vengono rintracciate alcune possibilità che la teoria e la pedagogia del teatro novecentesco ha messo a punto per accedere e rinnovare il “sentire performativo”: la divisione soggettiva, la ritrazione dell’io, l’impersonalità, la modalizzazione.
Pubblicato in “Biblioteca Teatrale”, n. 71-72, lug-dic 2004
Introduzione
Nel pensiero del Novecento l’esperienza estetica ha assunto una particolare configurazione: quella di una esperienza non vincolata alle emozioni, al sentimento e al sentire soggettivo. La desoggettivazione del sentire estetico operata dalla psicoanalisi e dalla più acuta filosofia del secolo scorso ha aperto, infatti, uno squarcio nel cuore del soggetto moderno.
Tutta questa grande vicenda filosofica, che non esito a considerare come la più originale e la più importante del Novecento, sta sotto la nozione di differenza, intesa come non-identità […]. Forse più che nell’orizzonte della pura speculazione teoretica, il suo ambito […] è proprio quello impuro del sentire, delle esperienze insolite e perturbanti, irriducibili all’identità, ambivalenti, eccessive di cui è stata intessuta l’esistenza di tanti uomini e donne del Novecento.[1]
Ed è proprio a questo ambito che rivolgiamo la nostra attenzione per comprendere alcune esperienze esemplari del teatro del secolo scorso.
Il cogito cartesiano che aveva sostenuto la fiducia in un io padrone e autore di se stesso, si sgretola sotto i colpi della filosofia – con Kant prima, poi con Hegel, Nietzsche, Husserl, Heidegger – e sotto i colpi della psicoanalisi con Freud e Lacan. L’io moderno non è più l’umanistico ripiegarsi su di sé, riflessione pura di un soggetto che si comprende e si disvela. È ora un vertiginoso dialogo tra il proprio essere multiplo e l’essere estraneo a sé stesso, tra il proprio essere finito e l’essere arbitrario.
Fino a Cartesio l’essere è stato pensato come sostanza e come soggetto; ha prevalso così una concezione dell’esperienza (affettiva e cognitiva) caratterizzata dall’affermazione dell’identità. Il riflesso di tale concezione, nella teoria dell’esperienza estetica, era l’egemonia del soggetto identificata nello stato affettivo. Al contrario, nel secolo scorso:
La desoggettivazione dell’esperienza condotta da Heidegger si determina come ricusa di due nozioni centrali dell’estetica soggettivistica: l’“espressione di esperienza vissuta” (Erlebnis-Ausdruck) e lo “stato affettivo” (Gefühlzustand). Per quanto concerne la prima, Heidegger contrappone ad essa il carattere essenzialmente linguistico dell’esistenza umana[2] […]. La seconda nozione rifiutata da Heidegger è quella di “stato affettivo”. Infatti, il concetto di sentimento è inseparabilmente connesso con la problematica del soggetto, cioè con la prosecuzione moderna della metafisica. Al suo posto Heidegger parla di una Grundstimmung, di una tonalità fondamentale che a differenza del sentimento non si limita a svolgere una funzione di mero accompagnamento, ma rivela il mondo e manifesta tanto l’essere quanto la sua mancanza. La tonalità (Stimmung) non è posta nel soggetto né nell’oggetto: infatti siamo noi che veniamo trasportati nella tonalità, la quale può essere definita coma una potenza che tutto abbraccia. Mentre il sentimento pretende una identità assoluta con se stessa, la Grundstimmung è insieme gioia e lutto.[3]
Per spiegare la natura di questo “sentire non soggettivo”, non personale, non psicologico, Heidegger utilizza la metafora del luogo aperto, della radura (Lichtung), un luogo non pensabile come delimitato, come forma, unità o identità. Essere in questo luogo ci permette di “sentire”, proprio perché qui ci troviamo “esposti” all’aperto, in un atteggiamento di abbandono nei confronti della differenza dell’essere. La nozione di abbandono (Gelassenheit) è centrale e richiama la posizione di ascolto, di impersonalità. Una posizione che è al di là delle antinomie (attività/passività, soggettivo/oggettivo), proprio perché l’alterità è nel cuore stesso dell’essere, è prossima, intima. Ritroviamo l’impersonalità nel cuore del soggetto, nel prima e nel dopo l’identità-io. Ognuno di noi può avere un accesso diretto all’Essere a condizione che il soggetto in quanto “ente” non si illuda di penetrare con la volontà o la forza del pensiero a cogliere l’Essere. È l’Essere stesso a rivelarsi parlandogli (Zuspruch). Per Heidegger, l’essere umano, l’ente, è in ascolto, il Dasein (l’esserci, l’essere aperto) è di natura piuttosto passiva: può solo ricevere lo Zuspruch in dolce tranquillità (Gelassenheit der Milde).
In merito all’arte, Heidegger rifiuta l’estetica soggettivistica, l’identificazione di soggetto e sentimento, rifiuta le nozioni di “esperienza vissuta” e “stato affettivo”; sostituendole con la tonalità impersonale (Stimmung): né soggetto né oggetto; pone l’opera come origine, anteriore al soggetto. È l’opera (la realizzazione estetica, il linguaggio, i sistemi simbolici) a precedere e a costituire il soggetto all’interno di una tonalità impersonale. Sullo sfondo di tali riflessioni, è possibile intravedere la fondamentale nozione di “differenza” che ha aperto l’esplorazione di zone sconosciute del sentire, irriducibili alle traiettorie dell’identità e dell’esperienza emozionale. Era stato Freud a mettere in atto la decostruzione più radicale dell’idea di “identità”, portando alle estreme conseguenze la rinuncia a un soggetto che coincide con la volontà e con la posizione attiva che lo spinge a racchiudersi e a contenersi nell’io sento, io voglio, io penso, io sono. L’inconscio è il luogo della differenza, della alterità interna. Lo smontaggio del soggetto positivo equivale al riconoscimento di una soggettività come passività e desiderio, una soggettività che trascende l’identità. Equivale alla separazione dell’io da se stesso. Separazione non ricomponibile sul piano dell’io riflessivo. L’io-identità non è padrone di se stesso, la pulsione, l’inconscio e la divisione (la Spaltung interna) lo scompigliano e lo pongono nella finitezza e nella parzialità, nella differenza e nella originaria “passività”.[4]
Che la soggettività parli in terza persona (lui, esso) e sia essenzialmente anonima, opaca e impersonale (la Cosa), è stato mostrato con tale evidenza da costituire la maggiore umiliazione per l’uomo moderno: l’io sa, vuole, agisce, credendosi al centro di se stesso, ignorando che “non è padrone in casa propria”. Tuttavia l’io è tale proprio perché tutto lo ri-guarda in prima persona, anche ciò che gli è estraneo e che gli “parla” in terza persona. Il compito della psicoanalisi è quello di portare l’io verso l’assunzione della sua divisione, della sua finitezza, della propria causa inconscia: Wo Es war, soll Ich warden. Riconoscendo le sue identificazioni, l’io si scopre determinato: saputo, voluto, agito.[5]
Due sono le implicazioni decisive sulla teoria dell’io/soggetto: a) tra io e soggetto non c’è identità, la differenza sta nel desiderio e, come in Hegel, nel desiderio del desiderio dell’altro; b) la finitezza del soggetto non è naturalistica, non è un limite naturale di capacità, non si tratta di rendere più potente, più indipendente, più ampio e ricco di sub-identità l’io. La finitezza è costitutiva, intrinseca alla struttura dell’io stesso, alla sua divisione, alla sua cattura nelle identificazioni, alla sua irrimediabile distanza da una realtà naturale e immediata. Il reale si cancella nella parola, il bisogno si cancella nel desiderio (come aveva mostrato Hegel). Il desiderio non è bisogno, la pulsione non è istinto, il reale non è l’io. L’io non è dell’ordine del reale, non è un pezzo di mondo. L’io, nel mostrare la sua identità immaginaria, nasconde il proprio nulla. Sottrarre le proprie identità immaginarie (identificazioni) fa sì che si tocchi il proprio nulla (via negativa). Con il saggio Il perturbante, Freud:
[…] va molto al di là dell’identificazione del differente con l’inconscio. Infatti, ciò che è veramente perturbante non è più soltanto un conflitto tra due poli non simmetrici (uno dei quali non può mai, per definizione, comparire sulla scena direttamente), ma il fenomeno dell’ambivalenza, la compresenza simultanea di un’affermazione e di una negazione, senza che da essa possa emergere un superamento dialettico. […] Questa è la massima differenza, l’esperienza più lontana dall’identità: non l’assoluta estraneità, ma una estraneità familiare […]: la differenza non è più un compromesso tra opposti la cui distanza è più grande della contraddizione dialettica (Hegel) e della polarità (Nietzsche), ma un’ambivalenza che unisce in sé in modo indistricabile identità e alterità».[6]
Io è altro, aveva detto Rimbaud. Riconosciamo una differenza, una forma obliqua, uno scarto, una ambivalenza nel vissuto corporeo ed emozionale. La differenza, intesa come duplicazione A+A1, non basta, perché è una variazione all’interno dell’identità; qui occorre dire la differenza come “ambi-valenza” che spacca in due l’identità, non per ricomporla, ma per lasciar vivere al suo interno il rapporto tensionale: A e non-A, identità e non-identità.[7] Come la filosofia, la psicoanalisi e l’arte, anche il teatro si è misurato con questo problema decisivo che fonda la soggettività moderna, trovandovi i motivi della sua incessante ricerca.
Riprendiamo i passaggi fondamentali del cambiamento avvenuto nella considerazione dell’io e del soggetto:
- L’io non è il soggetto
- L’emozione non è la verità
- Il soggetto “diviso” non può essere identificato con l’io “multiplo”.
- Io, soggetto, emozione, verità.
La distinzione tra io e soggetto è cruciale.[8] Il soggetto è dotato di una logica di funzionamento propria che non coincide con quella dell’io e che si manifesta nei sogni, negli atti mancati, nei sintomi, nei lapsus, nel desiderio, nei tagli…. L’io si presenta come una riduzione, una alienazione del soggetto dell’inconscio.
Una psicoanalisi, essendo propriamente l’esperienza del soggetto dell’inconscio, non può e non deve ridursi a una ortopedia dell’io, a un suo progressivo rafforzamento e adattamento […], poiché l’io non è il nucleo sostanziale del soggetto ma piuttosto il “sintomo umano per eccellenza”, la “malattia mentale dell’uomo”, la degradazione alienata del soggetto. L’io, dunque, non è il soggetto ma una forma di alienazione immaginaria del soggetto. L’io, infatti, come aggregato di una molteplicità di identificazioni “non sa nulla dei desideri del soggetto”. […] Io non sono là dove penso ma, esattamente a rovescio, il mio essere trascende il mio pensiero, l’essere del soggetto è, in altre parole, solamente là dove il pensiero della ragione egoica si eclissa. In questo senso, Lacan ha potuto affermare che l’inconscio è una sorta di trascendenza interna.[9]
La disgiunzione, la non coincidenza tra io e soggetto, indica che il luogo che costituisce il soggetto, al di là dell’io, è il luogo dell’inconscio. Per questo, afferma Lacan, «il progresso di un’analisi non riguarda l’ingrandimento del campo dell’ego, non è la riconquista da parte dell’ego della sua frangia d’incognito, ma è un vero capovolgimento, uno spostamento, un declino dell’immaginario del mondo, un’esperienza al limite della depersonalizzazione»[10]. Il soggetto diviso non è semplicemente un soggetto frammentato e moltiplicato, una serie di Io contingenti e reversibili. È un essere che non coincide con se stesso. Non c’è quindi un soggetto compiuto nella sua identità con se stesso. Proprio il taglio, la scissura tra significante e significato consente di scovare il soggetto che interessa propriamente la psicoanalisi.[11] Il significante[12] è la causa del soggetto, e inevitabilmente lo costituisce diviso. Non c’è, né ci sarà mai, una unità, una totalità o una presa diretta sul reale, poiché la mancanza è originaria (è prima di tutto). La mancanza-a-essere è un nulla attivo (non un vuoto), è uno scarto, una eccedenza di non-senso, un buco-nero che attrae a sé e non lascia uscire alcuna forma, nessuna rappresentazione che l’io possa guardare, utilizzare, significare. Qualcosa c’è, ma totalmente altro: non sono io, non è un egli ma Esso. Eppure questo qualcosa ri-guarda il soggetto, lo include. L’attività pulsionale mira a raggiungere quella perdita, quella mancanza che il soggetto sente e che lo vincola all’innominabile per eccellenza: la morte. Ecco perché il soggetto è desiderio, ma desiderio di…nulla. Eppure, è proprio a partire da tale decostruzione dell’io che si rende possibile un’intimità che è altra cosa dalla presenza a sé. Approssimarci a noi stessi vuol dire sempre sperimentare tutta la distanza che ci separa dall’ideale di una presenza piena e senza scarti: sperimentare un soggetto che si coglie proprio in questo scarto, vacillamento, taglio. Là dove vi è una non reperibilità a sé, lì sorge un soggetto che appare nell’istante in cui sparisce, dandosi a percepire come ciò che sempre sfugge.[13] Il vero soggetto, «il soggetto del desiderio, […] non è che la Cosa, la più prossima a lui e insieme quella che più gli sfugge».[14] La Cosa è per Lacan l’indice di una divisione originaria dell’esperienza della realtà. Ciò che tocchiamo del reale è il taglio, la faglia, il nulla.[15]
Era stato Kant (nella Critica della ragion pura) a enunciare la formula Ich oder Er oder Es (das Ding) [Io o Egli o Esso (la Cosa)]; secondo la quale il fondamento che sta dietro l’apparire sensibile dell’io va cercato nello slittamento verso un “egli” e, meglio ancora, verso un “esso” impersonale, verso un’istanza che non ha nulla a che fare con l’io sostanziale, cosciente, psicologico, empirico, un’istanza del tutto neutra e impersonale: una cosa, che sta lì, indipendentemente dai nostri pensieri, dal nostro sentire, dal nostro volere, dalla nostra storia personale. La persona come identità concreta, con una sua storia empirico-mondana, trova fondamento al di là di ogni psicologismo, nell’impersonale e nel neutro. Nella Fenomenologia dello spirito, di Hegel, l’Io viene definitivamente desostanzializzato. La soggettività è da reperire nello spazio, anzi nell’abisso che si apre tra coscienza sensibile e parola, tra autocoscienza e desiderio (o pulsione). Wir sind das Nichts (noi siamo il nulla): l’io non appartiene in nessun senso all’immediatezza del reale, né naturale, né vitale. L’autocoscienza non è la vita, semmai è il movimento verso la verità della vita, verità che eccede il sapere dell’io stesso. Una verità che l’io può riconoscere attraverso la mediazione del desiderio, desiderio “impersonale” in quanto non è dell’io ma dell’Es.[16]
Nietzsche inaugura la questione del soggetto secondo la doppia articolazione, che sarà il leitmotiv del Novecento: a) la deflagrazione e la molteplicità dell’io e dei vissuti, conseguenza anche della “scoperta del corpo”; b) l’alterità intrinseca all’io e la elezione della divisione a principio poietico. L’io, al di là delle garanzie di anima, sostanza, identità, cogito, si scopre incerto, senza fondamento. Non è possibile parlare di soggetto nel senso di “autore” dell’attività psichica, poiché l’io, la res cogitans, è una delle forme emergenti di quelle strutture stabili, permanenti con le quali l’istinto di conservazione della specie si auto-garantisce. A questa entità emergente e di superficie che chiamiamo io, individuo, identità, sfuggono i motivi, le spinte, l’origine e il senso della maggior parte delle azioni, dei pensieri, delle passioni. Tutto ciò di cui acquistiamo coscienza è costruito, schematizzato, semplificato, significato; il nostro mondo interiore, invece, è il regno dell’incerto, del mutevole, dell’oscuro, di ciò che è capace di trasformarsi. La decostruzione dell’io corrisponde allo smontaggio di quella piccola ragione che Nietzsche chiama Geist, a favore di un’altra “ragione”, che trova la sua origine non nell’io ma nel corpo. Quest’altra ragione “non dice io, ma fa io”, come sentenzia Zarathustra. Il superamento dell’io è condizione del fare artistico: «in ogni forma e grado dell’arte pretendiamo, soprattutto e innanzitutto: superamento del soggettivo, liberazione dall’ “io” e assenza di ogni volontà e capriccio individuale».[17] Il poeta tragico mostra una “meravigliosa divisione di sé” ospitando in sé lo spirito apollineo accanto a quello dionisiaco.
La fenomenologia di Husserl ha ripreso e approfondito la riscoperta della corporeità e l’alterità intrinseca al soggetto. Per Husserl (in Meditazioni cartesiane), il soggetto fenomenologico non ha nulla a che fare con l’introspezione, la percezione interna o lo stato interiore dell’esperienza di sé, puramente psicologica, né ha a che fare con la riduzione a corporeità (Körper). Il soggetto fenomenologico coincide con la “corrente di coscienza”: nessuna res cogitans, nessuna anima o sostanza regge da sopra o da dietro l’identità del flusso dei vissuti. Tale soggetto non è riconducibile né alla riflessione né alla consapevolezza. Husserl introduce l’espressione Ich-Spaltung ad indicare il riconoscimento della propria divisione costitutiva: come “io opaco”, “io assopito”, “io nascosto”. Il soggetto fenomenologico è altro dall’io empirico, è nella trascendenza del mondo empirico, del significato, non nella certezza del sapere positivo e nel possesso di sé. Pur essendo sempre “incluso” in ogni possibile esperienza, l’io empirico non ha un sapere su di sé: la sua verità è la sua differenza, la sua divisione. L’io è sempre di fronte ad un “superamento” a una ulteriorità nei confronti di se stesso, al di là di se stesso. In tal senso il soggetto fenomenologico è anti-psicologistico. L’esperienza può essere declinata al di là del vissuto, anzi, si potrebbe dire che si ha una esperienza autentica solamente quando è in gioco qualcosa di radicalmente altro, qualcosa di “assopito” e non intenzionale. L’idea di esperienza si dilata fino a comprendere qualcosa di assente, di mancante, di estraneo. Trascende la comprensione, la riflessione e anche l’emozione. La verità dell’esperienza è da ricercare nell’ulteriorità.
Una lettura problematica, che mostra come l’esperienza, in particolare quella emozionale, non abbia una presa diretta nel reale, né un accesso privilegiato alla verità, né alla “naturalità”. Lo psicoanalista J. A. Miller è stato molto perentorio: «si crede che l’affetto sia la testimonianza di un rapporto immediato con il vero. Nell’affetto il corpo testimonierebbe a sue spese l’effetto di verità – nella palpitazione, la sudorazione, la trepidazione: l’affetto direbbe il vero»[18]. Ma, come ci ha insegnato la psicoanalisi, l’affetto non dice sempre il vero. È da “verificare” volta per volta se un’emozione, pur manifestandosi con tutte le corrispondenti reazioni somatiche e viscerali, più che poggiare su una verità soggettiva non stia lì ad occupare lo spazio di un’altra cosa, una diversa emozione. Quindi, se il soggetto non si rapporta direttamente al reale, ma al linguaggio e agli effetti che questo ha sul corpo, è nei “modi” in cui il soggetto gira intorno al reale che potremo verificare l’affetto, e non nelle singole reazioni. I “modi” consistono nel significante e nel desiderio; vedremo come Grotowski e Bene troveranno in questa direzione le proprie soluzioni alla verità-presenza-emozione. Né l’identità, né la volontà, né l’esperienza corporea, né l’emozione sono garanzia della verità dell’essere, del soggetto.
L’idea di de-soggettivazione fa del corpo il luogo in cui si realizza l’oltrepassamento della stessa identità emozionale. Tali nozioni di esperienza e di corporeità non riposano però sulla concezione consolatoria della integrazione.[19] Come nota Alfredo Zenoni,
[…] uno dei vettori essenziali del ritorno a questo “essere-al-mondo” originario è stato l’esplorazione del coinvolgimento del corpo […], ma di un corpo che, a causa di questo stesso coinvolgimento, non può essere ridotto al semplice aggregato di funzioni e meccanismi descritti dalla fisiologia e dalla psicologia empiriche. Il coinvolgimento del corpo fenomenologico è difatti l’affermazione che il corpo è sempre qualcosa di più del corpo.[20]
Proprio a partire da tale visione si è imposto, nelle scienze umane, il confronto con quella che viene definita una “eccedenza” connaturata alla stessa idea di identità: l’io che fa esperienza di sé e del mondo si scontra con la impossibilità di proiettarsi in una coincidenza piena e pacificante nei confronti del corpo, del pensiero, della volontà e del vissuto affettivo.
1.1 Nell’arte
La scomposizione di un soggetto unitario, monolitico, autofondante, è leggibile nelle nuove correnti dell’arte del primo ‘900 (l’Impressionismo, il Cubismo), nella musica (la Dodecafonia), nella letteratura (Pirandello, Kafka, Joyce). Già l’Io del Romanticismo aveva annunciato il suo sfaldamento, “tuffandosi nel mare dell’inconscio”, dei processi notturni, ignoti, abissali, perturbanti. Le opere di E. T. A. Hoffmann, mostrano un morboso e insistente interesse per i fenomeni di sdoppiamento di personalità, interesse ereditato da Hugo, von Hofmannsthal, De Quincey, Musil, Beckett. «Sogni, visioni, allucinazioni e malattie tradiscono la presenza di quelle profondità dell’anima che […] sono nascoste nella notte».[21] Profondità che irrompono nell’io indebolendo i suoi confini e trascinandolo verso la dissociazione, la frammentazione, il naufragio. Il confronto con l’intima divisione soggettiva rischia di inghiottire l’io. F. Hölderlin, G. de Nerval, A. Artaud, V. Woolf: sono solo alcuni esempi di naufragi.
All’inizio del secolo, il superamento della visione positivistica dell’io cartesiano è stata una urgenza che ha attraversato le avanguardie e ha dato impulso a movimenti e a visioni estetiche anche molto distanti tra loro. Urgenza di uscire da una concezione dell’identità ormai vissuta come limitante, statica, su tutti i piani dell’esperienza, psicologica, politica, estetica; soprattutto dalla concezione di un “io” proprietario: dell’agire, del pensiero, della volontà, del vissuto, della immagine stessa della sua auto-rappresentazione.
Due sono state le vie percorse a fronte di questa scomposizione: da un lato la molteplicità dei vissuti o delle sub-identità; dall’altro la differenza, l’alterità intrinseca all’io stesso, espressione di una costitutiva divisione. La “molteplicità” si è declinata in: frammentazione, scomposizione, sub-identità, stati di coscienza, stati dell’io, il doppio, io multiplo, livelli di realtà, libertà dai vincoli, punti di vista, complessità, ermeneutica-semiosi illimitata, fascio di ruoli…La “differenza” si è declinata in: soggetto diviso, impersonalità, alterità interna, ambivalenza, io trascendentale, io è altro.
L’arte è il luogo in cui il linguaggio si rifà, si sovverte e si ricrea, dove si ritrova l’origine del soggetto e della sua Spaltung, come Heidegger aveva chiaramente intuito, esplorando il rapporto tra morte e linguaggio.[22] L’io poetico della modernità si inaugura proprio a partire da questo rapporto, da questo taglio. La poesia moderna nasce nel luogo specifico ove l’io dell’enunciato si riconosce nell’io dell’enunciazione per misurarsi con la propria vacuità e finitezza. Baudelaire inaugura tale posizione della soggettività.
L’aspirazione a una tonalità, a una posizione “ulteriore” da dove ascoltare “la segreta lingua delle cose mute”. Il poeta non è colui che pensa, sente e racconta un mondo oggettivo e visibile (posto davanti a lui), sono le cose che pensano e sentono dentro il soggetto; l’io è stato espropriato, assoggettato, con effetto di “mortificazione”. L’esterno si è intrufolato nel cuore del soggetto, costituendo una intima estraneità (Lacan ha parlato di “estimità”[23]). E al contrario, la soggettività, dispersa nelle cose, fusa in esse, esterna a sé, realizza una estraneità prossima al mondo (per Heidegger ek-stasis).
Comunque, tra io e cose, tra io e mondo non vige più un rapporto di “conoscenza”, di possesso, di identificazione. Il ritrovarsi del soggetto nelle cose avviene in perdita: non rimane alcun significato certo, solo la cifra di una differenza, di una estraneità. Il poeta enuncia a prescindere dalla sua personalità, contro di essa, al di là di essa. Il soggetto moderno è dunque lì dove si sdoppia: nel “riso”, nella “parodia”, nella “estraniazione”.
Così, in Rimbaud non si tratta di un generico ampliamento o moltiplicazione dell’io: “Io è un altro”[24] dirà e non “io sono un altro”. Dell’io, Rimbaud parla in terza persona, come farà Freud (l’Ich che deve av-venire all’Es). Autore dell’opera non è l’io biografico, psicologico, ma l’io che è un altro: l’io non dell’uomo ma dell’opera stessa, della scrittura stessa. L’io del poeta (non dell’uomo) è Bateau ivre. Così in Lautremont per il quale la scrittura poetica libera l’io dalla psiche, da tutto ciò che ha di personale (Canti di Maldoror).
Per P. Valéry la questione del soggetto è paradigmatica. Monsieur Teste, il suo alter-ego dei Quaderni, è un personaggio fluido che non ammette identità nelle azioni, nelle opinioni, nelle emozioni, nei desideri. Teste rigetta tutto ciò che è “personale”; oppone alla diversità dei vissuti, delle impressioni, alla singolarità di essere individuo, un “Io” che contiene e riassume tutto, un io universale che non ha nome né storia. L’orrore di Teste è la concrezione empirica, l’identificazione nella realtà quotidiana differenziata. Il suo desiderio è quello di essere “qualsiasi”, indifferenziato, diffuso nel reale, fuori da ogni identificazione, al di là di ogni qualificazione, pura “possibilità”. L’io è nulla, nulla in particolare. Per vie diverse è l’io in cui si proietta Musil/Ulrich. L’io empirico-psicologico, invece, crede a se stesso, si crede reale e separato, si prende maledettamente sul serio ed è incapace di sopportarsi come singolarità qualunque, a viversi come contingenza indifferente. Si sente padrone grazie alle proprie identificazioni, ai propri ideali, al proprio immaginario, alle proprie illusioni. L’io del poeta è l’antidoto a questa malattia. L’io del poeta è capace di una radicale solitudine, è un io già da sempre “qualunque”, anonimo, non-positivo, passivo, senza orgogli identificatori o consolazioni romantiche. La finitezza di questo io ascolta la Notte che avanza e si sporge sul proprio abisso (Spaltung). È la relazione con l’informe, con l’in-dicibile e l’in-significabile ad attrarre tanto i simbolisti quanto Rilke e Valéry, il quale dirà “l’io è il senza volto, senza età, senza nome, e un altro Io ha il mio nome, il mio volto”.
Per Rilke, la poesia (e l’arte in genere) non è una realizzazione, ma un ripiego. Non è affermazione, ma fallimento, è il resto di un fallimento. Anche nella vita del poeta, la scrittura non è mai una vittoria, l’espressione di una realizzazione, di un conseguimento. Con la sua opera il poeta mira a qualcosa che non riuscirà mai a raggiungere, ad avere; qualcosa da sempre desiderato e mai raggiunto. I versi sono una consolazione a questo fallimento. La diffusione dell’io e la molteplicità, come possibilità “liberatoria”, è un tema decisivo della filosofia, della cultura e dell’arte del Novecento. Per gli artisti, in particolare, la molteplicità dell’identità si è posta come traccia della prassi innovativa e creativa. La moltiplicazione dei punti di vista, dei modi e dei contesti della rappresentazione, dei principi e delle finalità del fare artistico, dei codici linguistici, dei temi, è stata sperimentata a tutto campo. In alcuni casi, come abbiamo accennato, la molteplicità dell’identità è stata assunta come soggetto dell’opera stessa. Alcuni hanno fatto della propria vita un campo di sperimentazione in tal senso; esempi estremi possono essere P. Klee e A. Artaud. Per Klee l’individuo è un organismo in cui convivono entità differenti: “il mio io per esempio è tutto un drammatico insieme”, ed elenca: un avo profetico, un eroe, un viveur, un dotto professore, un’innamorata lirica, un pedante papà, un parente indulgente, una zia chiacchierina …
L’io si moltiplica, si pluralizza, si espone al caso, si ironizza con il Dadaismo prima e il Surrealismo poi.[25] Dada canta la libertà, la disidentificazione, il gioco antipsicologico e anti-emozionale, ma in Arp l’io non riesce ad affacciarsi sulla sua intima divisione, rimane, pur nelle variopinte rifrazioni, un “io sono…” e non un “io è”. Nella letteratura saltano i codici linguistici, si moltiplicano i punti di vista mettendo in crisi l’univocità del narratore unico e onnisciente. Non sono solo i personaggi a farsi molteplici (ad esempio in Pirandello) ma è il narratore stesso a mettersi in crisi, ad annullarsi nel linguaggio (esempi eccellenti: Proust, Joice, Kafka). Allo stesso modo la dittatura dell’Io (ma anche la sua preziosa funzione ordinatrice e selettrice) viene contestata da quelle tecniche narrative come lo stream of consciousness che ambiscono a cogliere la magmatica mobilità della vita psichica, i rapidi e fluttuanti movimenti del subconscio o dell’inconscio profondo sotto la superficie piana della coscienza. Anche in questo caso all’ampliamento della conoscenza delle dinamiche interiori del personaggio si accompagna un indebolimento dell’Io che non può più porsi come unico o principale fattore della vita psichica.[26] Guardando all’opera di Kafka, L. Trilling ha messo in rilievo la crisi dell’Io e il senso di precarietà dell’identità moderna:
[…] non meno di Kafka, Shakespeare ci costringe a vedere la crudele irrazionalità della condizione umana. […] nella cella di Shakespeare […] i capitani e i re, gli amanti e i buffoni […] sono vivi e completi fino all’ora della morte. Ma in Kafka qualcosa di terribile è stato fatto ai condannati già molto tempo prima che la sentenza venga eseguita, anzi molto tempo prima che si istituisca il maligno processo. […] Essi sono stati spogliati di tutto quello che si addice all’uomo, tranne la sua astratta umanità. […] Sono senza parenti, senza casa, senza moglie o figli, senza impegno o appetiti, sono a loro estranei il potere, la bellezza, l’amore, l’ingegno, il coraggio, la lealtà, la fama; e il senso di orgoglio che si prova nel possedere queste cose. Così che possiamo dire che la conoscenza del male esiste in Kafka senza la conoscenza, con essa contrastante, dell’Io nella sua salvezza e validità; mentre in Shakespeare la conoscenza del male esiste accanto a questo contrasto, espresso il più fortemente possibile.[27]
Una parte, certamente delle più significative, della letteratura moderna e contemporanea scrive della crisi dell’io, documentandone le progressive fasi di disfacimento fino «alle soglie della disintegrazione quasi completa e del silenzio, che l’opera di Samuel Beckett, forse meglio di ogni altra, esemplifica».[28] Nel romanzo L’Innominabile, la dissociazione del protagonista diventa struttura narrativa portante. L’io del protagonista, scomposto in un caleidoscopio di identità che si mescolano e rimescolano, non assume mai forma stabile, definibile, identificabile – innominabile, appunto.[29]
In Finale di partita, Hamm esclama “Non ci sono mai stato”. C’è poi il titolo di un breve monologo: Non io, dove la protagonista parla di sé solo in terza persona. In Aspettando Godot, i protagonisti hanno perduto memoria, senso d’orientamento spazio-temporale, capacità di giudizio, coerenza emozionale. In L’ultimo nastro di Krapp, il protagonista si vive dissociato, scomposto in tanti individui diversi e indipendenti. Così Winnie si rende conto « di essere spaccata in due (“Sono ora l’una, dico l’una, ora l’altra. Ora l’una, poi l’altra”) e di vivere un’esistenza truccata dietro la maschera di un Io di cartapesta […] In Beckett, come generalmente negli scrittori dell’Assurdo, il linguaggio sembra aver perso ogni funzione di lógos ordinatore e ogni tonalità affettiva».[30]
Scegliendo di esplorare nella sua opera le strade desolate che portano al grado zero dell’identità e del linguaggio, […] Beckett si qualifica come il più significativo di quegli autori capaci di portare una radicale testimonianza della fragilità e della lacerabilità infinite della persona, e di cogliere nella propria interiorità le tracce e le indicazioni di quella scissione dell’Io che è tale da trascendere ogni semplice connotazione psicopatologica e da rientrare nell’area delle possibilità immanenti alla condizione umana.[31]
1.2 Nel teatro
Abbiamo accennato al fatto che nel pensiero, nell’arte, nella letteratura, si è infiltrata una dilagante percezione di sradicamento e frammentazione che ha comportato una impossibilità a raccogliersi interamente sia nel pensiero che nel corpo e nel vissuto affettivo. Il riconoscimento di questa eccedenza è emerso anche all’interno delle elaborazioni più avanzate delle arti performative del Novecento, quelle che hanno contribuito a riconsiderare la nozione di esperienza e di soggettività. Con l’affermarsi, nel corso del secolo, di un tipo di performance consacrata alla propria natura di evento affacciato su un presente assoluto, l’azione fisica del performer è stata concepita come una esperienza sempre più vincolata alla propriocezione e alla coscienza attiva del corpo.[32] Paradossalmente, proprio nella simultaneità di azione, emozione, motivazione e intenzione, che fondava il prodursi stesso dell’atto performativo, si sperimentava l’oltrepassamento dei confini di una soggettività intesa come io-pensiero-emozione. Più ci si concentrava sulla centralità del “vissuto” radicato nei confini dell’io, più si metteva in luce il carattere impersonale e, per alcuni versi, de-soggettivizzato della esperienza.
Un processo paradossale, nel quale si veniva a delineare una insolita convergenza tra la qualità fenomenologica del presente performativo e una nuova accezione di “esperienza” – fondata su una rinnovata idea di soggettività – che metteva in luce la non priorità dello stato emotivo, a vantaggio della condizione di “impersonalità”, quella stessa impersonalità incontrata dal performer di Grotowski e da Carmelo Bene (io è un altro). Con approcci e soluzioni diverse i “maestri del ‘900” si sono misurati sulla questione dell’esperienza e della verità, proiettandola nella utopia, nella pedagogia teatrale, e nella indagine sul lavoro dell’attore.[33]
Seguendo una linea ideale che dalle intuizioni dei maestri-pedagoghi del primo ‘900 giunge a Grotowski e Bene, è possibile riconoscere alcuni dei profondi cambiamenti di prospettiva che hanno segnato il pensiero e la pratica teatrale, soprattutto in riferimento alla questione del soggetto nella esperienza performativa. È infatti possibile cogliere un itinerario di riflessione che affronta, dall’interno dell’ esperienza dell’attore, le contraddizioni generate dallo statuto stesso della rappresentazione. Lungo questa linea ideale, le articolazioni, le dislocazioni e le polarità che investono l’io del performer sono state esperite in maniera sempre più precisa.
Il teatro, per i suoi stessi statuti convenzionali, non poteva che essere parte attiva nel progressivo superamento della visione statica della identità, in una progressiva elaborazione della molteplicità, prima, e della divisione costitutiva, poi. L’idea stessa di rappresentazione, infatti, ha tradizionalmente configurato l’io dell’attore nella moltiplicazione delle identità simulate dei personaggi; un attore chiamato a costituirsi in ego diversi, a riprodursi nella imitazione, nella simulazione psicologica, comportamentale, gestuale del personaggio: «È evidente che l’Io si pone come immagine dominante e unitaria che legittima e fornisce consistenza al linguaggio e all’espressione, al dire cosciente e intenzionale e al dire simulato; poiché è nell’Io che si realizza l’istanza di rappresentazione».[34] L’attore si fa interprete dei molteplici ruoli drammaturgici e sociali dell’Io.
Facendosi carico, all’interno del proprio operare, del portato di moltiplicazione implicito nel vissuto scenico, molta parte del teatro del Novecento, si è impegnato non solo a modificare la accezione positivistica dell’io, ma anche, e soprattutto, ad approfondire il percorso della articolazione e della dislocazione della identità, arrivando a prospettarne la ritrazione nella impersonalità o nel corpo-marionetta. L’apporto dei maestri-pedagoghi è stato fondamentale all’interno del panorama artistico e culturale che spostava definitivamente i confini dell’io “positivo”. Il lavoro condotto dai primi maestri è prova della volontà di oltrepassare quei confini, ma non solo; attraverso una “istanza di verità” sempre più puntuale, si cominciavano a minare anche le radici dello stesso statuto di frammentazione e molteplicità dell’ “io” che sta alla base della rappresentazione.
I “maestri del ‘900” si sono misurati sulla questione fondamentale del soggetto come costrutto dinamico in cui si articolano i processi della creatività, della socializzazione, della incorporazione, dello svelamento, della rigenerazione, della differenza …Tuttavia, la ricerca di una verità scenica che aspirava ad essere più vera di quella quotidiana, tendeva in alcuni casi a restare ancorata al binomio io-emozione.
Nel pensiero teatrale della prima parte del ‘900, “io” ed “emozione” apparivano ancora reciprocamente giustificati e consegnati nelle mani dell’attore a sostegno di una istanza di autenticità che, attingendo alla memoria emotiva o al subconscio, intendeva far coincidere di volta in volta le proprie emozioni con l’io del personaggio. Anche la rilettura novecentesca della improvvisazione ha lasciato l’emozione al centro della identità, quale materiale personale privilegiato per raggiungere e costruire la partitura e con essa il personaggio. Si guardava alla unità (anche etica e sociale[35]) passando per le possibili parti che la costituiscono; nel cercare un soggetto rinnovato o “uomo nuovo”, ci si muoveva all’interno della articolazione dei diversi gradi dell’io ma ancora … in vista di una risolutiva “integrazione”.
Al centro delle principali visioni del teatro – come nella vita culturale e artistica – che hanno segnato la prima parte del XX secolo è possibile rintracciare il perdurare di una costante della cultura occidentale, vale a dire la propensione a considerare l’io (con i suoi contenuti emotivi) come coincidente e sovrapposto al soggetto e, in molti casi, a osservare l’uno per descrivere l’altro. Ma bisogna anche ricordare che il lavoro condotto dai riformatori del ‘900, intorno alle radici della istanza stessa di rappresentazione, pur restando ancorato ad una concezione identitaria, ha avuto il merito, quasi rivoluzionario, di gettare le basi di una profonda trasformazione. Nella pedagogia teatrale, infatti, venivano affrontate e tradotte in esperienza nuove prospettive intorno alla nozione di soggettività. Si faceva strada – in accordo con la riflessione filosofica e psicoanalitica – la necessità di riconoscere la distinzione, apparentemente elementare ma in realtà essenziale, tra io e soggetto.
È stata la capacità di intravedere questa distinzione e di portarla gradualmente in superficie, anche senza esplicitarla direttamente, a mettere in moto le profonde trasformazioni che hanno portato alla messa in discussione dello statuto stesso della rappresentazione. Per raggiungere quelle trasformazioni, sono stati necessari alcuni non facili spostamenti di prospettiva che cercheremo di ricostruire, seppure in una sintesi inevitabilmente parziale. All’interno dello statuto tradizionale della rappresentazione, al soggetto-attore si imponeva l’assunzione di un ruolo che, non potendo coincidere con la sua soggettività, richiedeva inevitabilmente la proiezione di parte della propria identità in quella dei personaggi. Il rapporto fra rappresentazione (i ruoli dell’Io) e soggettività, implicava l’apertura di uno scarto in cui molte esperienze teatrali e pedagogiche sono state catturate e costrette a mostrare le loro contraddizioni. Soprattutto là dove la rappresentazione si voleva naturalistica, coerente, verosimile, vicina alla realtà.
Come nel pensiero filosofico il superamento del positivismo avveniva mettendo in crisi l’idea di identità, di pensiero logico-coerente, di io volitivo, di realtà naturale, allo stesso modo, nel teatro, si andava oltre lo statuto naturalistico di rappresentazione mettendo in discussione la centralità dell’io, della coerenza, dell’imitazione e mettendo in crisi l’equivalenza sentimento=verità.[36] Queste soluzioni saranno il campo di sperimentazione della corrente simbolista e delle avanguardie storiche.
Nel 1896, con la prima di Ubu Re di A. Jarry, inizia l’avanguardia teatrale sotto il segno dell’antinaturalismo, della parodia che sberleffa ogni istanza identitaria (una demolizione che avrà solo in Kafka una pari efficacia). I personaggi sono caricature marionettistiche, goffe, con voci meccaniche, tic verbali, lapsus e frequenti non-sense. «Ubu è la marionetta senza passione, nata da uno scherzo goliardico e presto diventata stendardo dello sberleffo al personaggio e alla parola individuale» e Jarry viene riconosciuto come «il padre dell’avanguardia teatrale nella sua fase infantile, negatrice e carnevalesca. Un’avanguardia che mina consapevolmente il personaggio come individuo, soggetto e centro del mondo da rappresentare […]. L’analisi della drammaturgia di Ubu Roi conferma lo scardinamento dell’azione lineare naturalistica, qui espansa in quadri moltiplicabili all’infinito, come sono moltiplicabili le avventure e i tratti caratteriali del protagonista»[37]. Così, in un sol colpo, Jarry ridicolizza ogni naturalismo e si porta al di là della seriosa scena simbolista.
Quando la nuova sensibilità e l’esigenza di rifondare i presupposti della rappresentazione cominciano a essere teorizzate, la critica investe la scena naturalistica, l’identità psicologica e persino il corpo naturale dell’attore. Ad esempio, la presenza stessa dell’attore sulla scena appare, a Maeterlinck, contraddittoria al punto da auspicarne la sparizione: «Forse un giorno per mezzo della scultura, potrà capitare che l’essere umano sia sostituito da un’ombra, un riflesso, una proiezione di forme simboliche, un essere che abbia le movenze della vita senza avere la vita. Non so se questo avverrà: certo l’assenza dell’uomo sulla scena mi sembra indispensabile».[38]
Le parole d’ordine sono sottrarre, astrarre, stilizzare: annullare l’identità naturalistica che impedisce la manifestazione di realtà più vitali, profonde e universali. La fisicità quotidiana dell’attore è riduttiva. A questo punto, due direzioni si aprono alla sperimentazione primonovecentesca: a) l’intuizione del “corpo vivente”, rigenerato, garanzia dell’unità e dell’integrazione e b) la constatazione del divario abissale tra corpo e coscienza e la conseguente proposta di un “corpo impersonale”.
In queste due direzioni si avviano Appia e gli espressionisti da una parte e Craig e il primo Mejerchol’d dall’altra. Appia risolve la divisione corpo/coscienza “vivificando” il corpo dell’attore attraverso il principio ordinatore e unificante della musica. La coscienza non può fondersi con il corpo e padroneggiarlo, solo un elemento esterno e superiore è capace di “contenerlo” e dirigerlo: la musica.[39]
Su questa linea vanno lette diverse esperienze dell’espressionismo teatrale (anche di Emmel, Fuchs, Berger), che, portando in campo il corpo organico-vitale, trova una terza via rispetto al naturalismo e al simbolismo. Fuchs, ad esempio, incarna perfettamente l’assunzione di due temi fondamentali, quali la riscoperta del corpo vivente e la ritrazione dell’io psicologico dell’attore:
[…] da un lato una pronuncia antiintellettualistica e antiletteraria che gli consentiva di vaticinare l’avvento di un teatro puramente “teatrale”, costruito sul ritmo o, meglio ancora, sulla danza, vale a dire su cifre “organiche”, riportabili al corpo dell’attore; dall’altro la consapevolezza, maturata sulla lettura di Nietzsche, che tale ritmicità non è fine a se stessa, ma lo strumento attraverso cui l’uomo, in quanto individualità finita, esperimenta il suo ritorno nel Tutto. […] Il teatro è il luogo dell’armonia ritrovata. Ma tale armonia si riattiva attraverso il sacrificio, la morte, più precisamente la morte del “primogenito”, metafora dell’io che deve patire l’ “orrore della fine” se vuole reimmergersi nel tutto e riaffiorare rigenerato.[40]
Craig, invece, risolve l’imperfezione dell’attore, prigioniero dello scarto tra coscienza-emozione-azione, attraverso la cancellazione del corpo organico-vivente. La perfezione verrà dalla disincarnazione dell’attore con la “Supermarionetta” da una parte (la marionetta ignora la differenza interna al soggetto, tra soggetto e oggetto, tra coscienza e corpo) e attraverso la sintesi registica dall’altra, funzione che assicura l’unità del teatro al di là dello psicologismo dell’attore e del naturalismo della scena. Il divario incolmabile tra corpo e coscienza non viene assunto nella sua portata, ma spinge Craig a cercare soluzioni riparatrici: annullare l’organicità e realizzare l’unità in una funzione esterna al corpomente dell’attore, nella regia. Il radicale programma di Craig è la cancellazione teatrale dell’organico in nome dell’inorganico: la Supermarionetta è una «entità fatta di sottomissione e silenzio, antitesi dei risvolti emozionali della figura umana […]; la perfezione umana non si esplica attraverso l’entità corporea da cui si è in qualche misura limitati, ma tramite uno strumento meccanico che rappresenti la proiezione del nostro Io più esaltante».[41]
Secondo Craig, dobbiamo «renderci conto che l’uomo non potrà mai più pretendere o proclamare che la sua persona è il mezzo degno e compiuto per esprimere il pensiero perfetto».[42] Le emozioni sono l’ostacolo più grande:
[…] per produrre un’opera d’arte qualsiasi, possiamo lavorare soltanto con quei materiali che siamo in grado di controllare. L’uomo non è uno di questi materiali […]: le azioni fisiche dell’attore, l’espressione del suo volto, il suono della voce, tutto è in balia dei venti delle sue emozioni.[43]
[…] non dovrebbe più esserci una figura viva atta solo a confonderci, facendo tutt’uno di “quotidiano” e arte; non una figura viva nella quale siano percettibili le debolezze ed i tremiti della carne. L’attore deve andarsene, e al suo posto deve intervenire la figura inanimata – possiamo chiamarla la Supermarionetta.[44]
Vediamo come Craig non rinunci all’idea di unità, identità, completezza, perfezione, semplicemente vuole realizzarla attraverso la dislocazione dell’io-corpo nella Supermarionetta e attraverso la sintesi registica.
Tuttavia, al di là delle soluzioni proposte, ci sembra centrale la necessità che Craig avverte di portare il teatro “oltre” i confini personali dell’attore: «Io non credo assolutamente nella magia personale dell’uomo, credo soltanto nella sua magia impersonale» e, nella nota alla parola “impersonale”, Craig chiarisce che «se è vero che ciò che c’è di impersonale nell’essere umano sia la parte migliore di lui; quello che è personale viene soltanto in secondo piano. A prima vista, sembra che sia l’elemento personale insito nelle cose a conferir loro un carattere peculiare e a costituirne l’identità; ma, a pensarci più ponderatamente, vedremo che perdendo la nostra personalità, ci guadagniamo, poiché siamo immersi in una forza nuova, distinta da ogni altra, superiore ad ogni altra».[45] Così sembra farsi avanti quell’idea di teatro che Angelini[46] non ha esitato a porre come base di tutto il Novecento: l’idea di andare al di là del reale manifesto nel fare i conti con gli aspetti più oscuri, obliqui, impersonali dell’essere.
Questa vita di carne e sangue, che noi tutti amiamo, non è per me qualcosa in cui frugare e da riprodurre innanzi al mondo, sia pure in forma convenzionale. Credo che la nostra aspirazione debba essere piuttosto cogliere una lontana, breve visione di quello spirito che chiamiamo Morte – evocare cose belle dal mondo immaginario.[47]
[…] La Supermarionetta non competerà con la vita – ma piuttosto andrà oltre. Il suo ideale non sarà la carne e il sangue ma piuttosto il corpo in rapimento: aspirerà a vestirsi di una bellezza simile alla morte.[48]
Anche altre esperienze dell’avanguardia artistica e teatrale hanno cercato nell’impersonalità una verità più alta. Collocandosi nella divaricazione aperta tra “marionetta” e “corpo vivente”, Schlemmer, ad esempio, mette in scena il corpo umano stilizzato geometricamente, liberato da ogni riferimento naturalistico e da ogni connotazione psicologica. «La magia impersonale di cui parlava Craig, invocando l’avvento della Supermarionetta, diventa, qui, rifiuto ostinato del principio d’individuazione: protetto dalla maschera, fasciato dal geometrismo di costumi che ne amplificano il valore simbolico, il corpo vivente dell’interprete attinge a una quintessenzialità divina».[49]
Mejerchol’d raccoglie, compie e confuta allo stesso tempo, l’eredità di Craig. Rifiutando lo psicologismo, l’emotività e l’auto-espressione dell’attore, lo trasforma in un organismo-congegno senza sbavature psicologiche. È Mejerchol’d stesso a riformulare l’eredità di Craig: «Quando Gordon Craig parlava di “supermarionetta”, non voleva dire che bisognava gettare via l’uomo per sostituirlo con un fantoccio, ma piuttosto che l’attore doveva acquisire una tecnica che lo rendesse simile a una marionetta».[50]
Evitando la recitazione interiore e l’immedesimazione, l’attore voluto da Mejerchol’d fa arretrare il suo io facendo emergere una fisicità trasparente, reazioni fisiche epurate da intenzioni.
Per Mejerchol’d il teatro deve abbandonare l’idea di rappresentare la realtà o il testo, e la scena non deve avere una funzione illustrativa. Sia la scena che gli attori non esprimono contenuti e sentimenti, non illustrano né espongono, ma la stilizzazione, il ritmo, il corpo bio-meccanico conseguono la “impersonalità”, la de-soggettivazione. La rottura della scena naturalista, dello stile imitativo e realistico, coincide con la decostruzione dell’istanza identitaria. L’attore si scinde in un artefice e nel materiale da plasmare.
In ogni attore che si accinga a lavorare a un personaggio si trovano come due persone: una prima persona, cioè lui, l’attore, una presenza fisica, un corpo in procinto di dar vita a un dato personaggio (A1), e una seconda persona che in pratica non esiste ancora, ma che l’attore si appresta a mandare in scena in una forma già compiuta (A2). A1 sta ad A2 come l’artista sta al materiale su cui lavorare (Mejerchol’d, L’attore biomeccanico, p. 60).
In Stanislavskji, la necessità di costruire un “sistema” sembra la risposta “all’abnormità della condizione dell’attore”, costretto a sdoppiarsi, a dislocarsi nel personaggio, a controllare i suoi stati emotivi e psico-fisici. La psicotecnica presuppone però, dietro le metamorfosi, una identità unica:
Se la creazione attoriale, comunque la si configuri, è largamente affidata all’azione di forze inconsce, di cui non è possibile conoscere le quiddità interne ma semplicemente gli effetti, è anche vero, a parere di Stanislavskij, seguace delle teorie della psicologia sperimentale, che la natura umana riposa su una sostanziale unità psicofisica, sicché la parte volitivo-cosciente non può non inferire sui processi involontari.[51]
Parallelamente, il primonovecento ha elaborato proposte che ponevano in maniera diretta la possibilità di far coincidere coscienza-emozione-azione.
Stanislavskij sfiora la divisione soggettiva ma la “risolve” nella molteplicità, nella proiezione delle identità virtuali dei personaggi: «Rappresentare sempre, solo se stessi, ma nelle varie combinazioni di problemi, di “circostanze date” che l’attore elabora dentro di sé per le diverse parti, fondendole nella fornace dei ricordi emotivi».[52]
Il problema per Stanislavskij è come raggiungere coscientemente quegli strati dell’esperienza personale che giacciono sotto la soglia del pensiero e della percezione; è una soglia che si può varcare:
[…] è una fortuna dunque che non ci siano confini netti tra rievocazioni coscienti e rievocazioni subcoscienti. Non solo, ma spesso la coscienza indica proprio la direzione in cui l’attività subcosciente può continuare a svolgersi.[53]
C’è una parte della nostra anima che noi chiamiamo coscienza e volontà. Questa parte ha la facoltà di influire sui nostri processi psichici involontari.[54]
“Il sub-cosciente attraverso il cosciente”. In altre parole, il “sistema” era un modo per razionalizzare e riportare nell’alveo della volontà e del controllo, l’istanza dell’intima alterità. Il principio della reviviscenza mostra una concezione dell’inconscio come un armadio, “serbatoio” di contenuti, emozioni, sensazioni di cui poter disporre.
«Anche la nostra memoria è un archivio. Anche lì scaffali, scatole e scatolette. Alcune a portata di mano, altre meno».[55] Non c’è Es, la transazione è da un io-passato a un io-presente. Anzi, anche nella tecnica del “magico se”, l’attore passa dalla terza persona (il personaggio) alla prima persona (le sue personali emozioni), abbattendo anche l’estraneità dell’altro esterno, dopo aver annullato quella dell’altro interno.
Questa ossessione del controllo, questa necessità che il flusso del subconscio fosse evocato, ma nello stesso tempo arginato, dalla vigile presenza dei poteri volitivo-razionali, è, d’altro canto, l’elemento connettivo tra lo Stanislavskij del periodo pre-rivoluzionario, ancorato a un sottile psicologismo, e le sperimentazioni dell’ultima fase in cui, sotto l’influsso della teoria pavloviana dei “riflessi condizionati”, sono le azioni fisiche a farsi latrici delle equivalenti connotazioni psicologiche. Nell’un caso e nell’altro, è il meccanismo del “riflesso” a dominare: in termini più precisi, la presenza di una causalità cosciente che si fa auspice di un effetto inconscio.[56]
Affidarsi alle determinanti personali, emotive, mnemoniche dell’attore voleva dire trascurare il fatto che le leggi del teatro non sono “esattamente riconducibili a quelle della psicologia”, che l’emozione ordinaria è diversa dall’emozione estetica.
Stanislavskij respinge la teoria dell’imitazione e della rappresentazione esteriore, cercando la verità nell’io dell’attore[57] quale ponte unico verso il personaggio. È sulla verità di questo io che si gioca la partita. Ma non è l’io quotidiano, privato che ci garantisce questa verità bensì l’io creativo. L’attore deve attingere al suo io nascosto, subconscio e allargare il suo io quotidiano: deve migliorarlo, arricchirlo. Io creativo e ricchezza di vita interiore si corrispondono. Come ha notato G. Guerrieri, si «stabilisce così una tensione continua, triangolare tra io privato, io creativo e io-personaggio».[58]
La questione della verità si pone in Stanislavskij nella sua autoevidenza:
Alla verità non si può non credere e se ci sono verità e convinzione, l’ “Io sono” si crea spontaneamente. […] Ecco l’importante novità: la più insignificante azione fisica o spirituale, capace di produrre un momento di autentica verità (e relativa convinzione), se portata fino all’ “Io sono”, è capace di mettere in moto tutta la natura spirituale ed organica dell’attore assieme al subconscio. […] Nelle rappresentazioni, nelle immagini, nei giudizi, sensazioni, desideri, nelle piccole azioni fisiche e spirituali, nei dettagli insignificanti delle invenzioni della fantasia, in un oggetto che avete sottomano, nei minimi particolari dell’allestimento scenico, nella messinscena. Ovunque voi potete cercare una piccola, umana, autentica verità che riscuota la vostra fiducia, e crei l’ “Io sono”.[59]
Nell’ “Io sono” si congiungono attore e personaggio, emozioni passate e presenti. La verità dei contenuti interiori può corrispondere alla verità dell’emozione scenica. Tra vita, emozione, corpo e anima non c’è separazione assoluta ma articolazione possibile. All’azione interiore corrisponde un’azione esteriore.
A riformulare questa articolazione sono chiamati anche i nuovi orizzonti della improvvisazione.
Dalla improvvisazione intesa come pura invenzione, legittimazione che conferma l’io nella propria storia emotivo-personale, man mano si arriva, nella indagine novecentesca, alla improvvisazione come strategia per implicarsi al di là dei meccanismi dell’io, statici e ripetitivi.
Il fascino per un nuovo tipo di improvvisazione, che si richiamava alla Commedia dell’Arte, ha accomunato molti pedagoghi (Coupeau, Mejerchol’d, Dullin, Jouvet) nell’idea di un “attore non progettato”. Copeau scopre, nel lavoro al Vieux Colombier, l’efficacia straordinaria dell’improvvisazione come montaggio di materiali, e la pone al centro della sua pedagogia volta non solo a educare l’attore ma a rifare l’uomo, a far emergere l’uomo nuovo. Così l’improvvisazione è al fondo della grande linea pedagogica del teatro del ‘900, là dove il bisogno di far teatro si proietta non sullo spettacolo ma sul lavoro di teatro, sul processo creativo dell’attore. E assume diversi significati, da sinonimo di creatività a una tecnica di rappresentazione, a montaggio (non) premeditato di elementi acquisiti.[60]
L’improvvisazione, in quanto ricerca di ciò che non si conosce, è un modo per far emergere il nuovo ed esorcizzare la ripetizione, grazie alla ricombinazione di materiali è possibile far emergere un nuovo attore un uomo nuovo. Si lega così la nozione di verità non più all’emozione, ma alla novità e al montaggio. L’idea di rifare l’uomo attraverso il teatro è ancora in un orizzonte “positivo”, la stessa strategia dell’improvvisazione è intesa ora come “creatività” (esprimere ciò che non si conosce), ora come “abilità” acquisita (possedere la partitura per essere liberi), quasi che la libertà dell’attore fosse legate alla quantità e alla novità dei materiali personali da combinare e variare, ottenendo la dilatazione, la moltiplicazione (non la differenza). Così, in Copeau «l’attore dilata “passivamente” il proprio universo psichico nelle dimensioni dell’immagine fantastica, attraverso il possesso di sé per “darsi” l’organizzazione di sé (“mestiere” e “sincerità come costruzione”)».[61]
L’indagine sulla improvvisazione identifica il punto di congiunzione tra il processo creativo dell’attore e il processo personale di trasformazione.[62]
Il disagio che gli artisti del primo Novecento hanno avvertito così forte nei confronti di una visione naturalistica, positiva, compatta dell’essere umano e del mondo in genere, si è tradotta in urgenze di superamento attraverso l’invenzione di strategie del molteplice. L’impersonalità della marionetta e la riscoperta del corpo-vivente, misterico, la scomposizione dei codici, la decostruzione, il principio del montaggio, l’improvvisazione, sono alcune di queste strategie, riconducibili alla condizione che Cruciani ha chiamato “attore non progettato”. Strategie che in diverso modo hanno cercato di rispondere alla percezione sempre più lacerante della divisione soggettiva. L’improvvisazione, ad esempio, rivelava uno scarto, un non-conosciuto all’interno di se stessi, che la volontà, la memoria e la tecnica codificata non riuscivano mai a raggiungere. L’attore non progettato dei teatri del Novecento è l’attore che fa i conti con la sua intima divisione e si lascia aperto ad accogliere i segni-sintomi che provengono dall’ “altro” rimbaudiano. Persino quando c’è un rifiuto radicale di tutto ciò che rimanda a spirito, anima, profondità, psicologia, alterità interna… il confronto con l’eccedenza non può essere eluso e lo scarto viene proiettato nell’alterità storica e sociale.
Se il teatro del primo Novecento trova la sua cifra nella eccedenza dei limiti razionali e percettivi, Brecht sembra dirci il contrario, e cioè che occorre liquidare l’eccesso, la funzione inconscia a favore di una dialettica della presa di coscienza. Tutte le innovazioni tecniche di Brecht (rottura della percezione “omogenea” dello spettacolo, recitazione che impedisce l’identificazione, presenza sulla scena del lavoro materiale solitamente celato, concezione “epica” della rappresentazione), pur obbedendo alla tensione verso l’articolazione e la decostruzione dell’omogeneità (sia scenica, sia dell’io dell’attore in rapporto al personaggio), hanno lo scopo di riaffidare all’io una nuova forma di padronanza.
Di fatto tutto accadeva per Brecht come se l’inconscio non esistesse, come se ogni soggetto fosse trasformabile razionalmente (prestigio della pedagogia), come se la psicoanalisi fosse solo un’astuzia della borghesia […]. Infatti per Brecht deve essere scartato tutto quello che sovverte la logica della padronanza. In altri termini, quando si diffida dei limiti dell’“io”, non è per postulare, come i freudiani, un soggetto diviso e abitato da una verità di cui non sa nulla e che lo determina ma, anzi per porre la necessità di uno strapiombo, di una “distanza”, di una padronanza ancor più compiuta. Insomma, dove Freud scopre che è la modalità stessa dell’esistenza dell’inconscio a fare della padronanza il luogo delle illusioni soggettive, Brecht non vede che una padronanza troppo ristretta, non abbastanza “storica”. Sarebbe d’altronde più giusto dire che anche Brecht, a modo suo, postula un soggetto diviso: ma opponendo all’ “io” le illusioni, non un “es”, ma un “io” superiore, storico, stratega, che deve saper trattare il primo “io” come un “egli”. Insomma, una piccola strategia o un piccolo stato in ciascun soggetto, per correggere meglio le sue illusioni o per meglio sorvegliare le sue erranze.[63]
Questa nostra sintesi delle diverse soluzioni adottate dalle avanguardie, non deve distogliere dal fatto che le tante invenzioni erano risposte ad una unica questione, ad un unico problema: la rottura dell’omogeneità dei linguaggi e dell’identità, che il teatro non poteva non affrontare. Ma è solamente con Artaud che questa fondamentale questione viene riformulata in modo radicale, portando l’approccio alla rappresentazione molto oltre l’istanza dell’io molteplice.
 2. Dall’io molteplice al soggetto diviso: Artaud
2. Dall’io molteplice al soggetto diviso: Artaud
Artaud ha fatto esplodere, in forma estrema, la questione centrale del soggetto perché ne ha incarnato la condizione di lacerazione, di divisione, di intima differenza e alterità. Non è più l’alterità delle moltiplicazioni dell’io, bensì l’alterità del “taglio” della Spaltung. Con Artaud è emersa la consapevolezza (tragica) che l’io è abitato da una eccedenza, non riducibile alla coscienza e nemmeno al vissuto emozionale.
L’irriducibilità sperimentata da Artaud conduce inevitabilmente a un rovesciamento della visione dell’io, per avanzare in una prospettiva che non si accontenta più di una molteplicità accettata e sperimentata ma aspira a misurarsi diversamente con quella eccedenza del soggetto. Il problema è come «fare dell’esperienza scenica un atto di vita che, attivando il contatto con le sorgenti del mondo pulsionale, incida sulla mente e sui sensi dello spettatore, come toccare la sfuggente giuntura che unisce lo spirito al corpo».[64]
Sono stati individuati momenti diversi dell’avventura artaudiana, momenti che articolano la questione fondamentale: il teatro deve essere un modo per rifare la vita, non per imitarla.
In un primo momento (che coincide con le prime esperienze 1921-25) Artaud cercava nel linguaggio del teatro la verità che lo rendesse credibile; voleva «che l’attore non si facesse strumento per significare la sua emozione, ma che vi si annullasse. O meglio, che si annullasse di fronte alla sua emozione. Grazie a questo annullamento, l’emozione si sarebbe manifestata nella sua assoluta verità».[65] In questa fase Artaud si poneva in continuità con molti maestri pedagoghi del primo Novecento: la ritrazione dell’io doveva garantire la verità scenica.
In un secondo momento, riferibile all’esperienza del Teatro Alfred Jarry (1926-30), Artaud si concentra sulla vivificazione delle materie espressive (parola, gesto, movimento, spazio) in cui l’attore è parte di un linguaggio reso concreto.
In una terza fase (il teatro della Crudeltà, 1930-45), il linguaggio non è solo concreto ma immediato, efficace, in grado di trasformare il corpo-mente dell’attore e dello spettatore. In questa fase, Artaud si inoltra nei territori oltre-teatrali, nei luoghi e nei saperi dove si rifà la vita, si rifanno i corpi e la mente. Qui il teatro acquista in pieno la sua concretezza ed efficacia, nella ricerca di strumenti in grado di istituire nell’attore una corrispondenza fra interno ed esterno, fra sentimenti ed espressioni, fra corpo e spirito. [66]
Infine, il cosiddetto periodo del Secondo Teatro della Crudeltà (1945-48), nel quale il superamento del teatro si radicalizza nella disperata ricerca di rifare l’anatomia del corpo per guarire la lacerazione soggettiva.
Ma già nel 1924, Artaud denunciava un drastico «sprofondamento centrale dell’anima, una specie di erosione, essenziale e fugace del pensiero, qualcosa che, se pur non mi impedisce di essere quel che potrei essere, mi lascia, per così dire, in sospeso».[67] Sospeso… su un vuoto, insostenibile. Neppure il teatro riuscirà a colmare questa originaria mancanza ad essere.
Il principio della dissociazione è fondamentale per comprendere l’idea di teatro di Artaud. Attivare il contatto con le forze dell’inconscio comporta una temporanea remissione dell’io da parte dell’attore e lo spettacolo è la ritualizzazione di questa morte simbolica; l’effetto è l’angoscia della perdita, del vuoto.
In tal senso, Artaud sta come spartiacque tra una idea di teatro fondata sullo statuto di molteplicità dell’io e una idea che trasforma radicalmente il teatro perchè lo fonda sulla lacerazione che investe il soggetto, inchiodandolo alla necessità della dislocazione e al confronto con la eccedenza.
Artaud incontra tragicamente i segni di un io che non può collimare con il corpo, perché nessuno dei due esaurisce l’altro, né l’ipotesi di una loro integrazione può riassorbire il soggetto. Si pone all’estremo, dove l’opera interroga la follia, nel luogo dove emerge l’impossibilità di arginare il corpo diviso in organi, frammentato, nella lotta (ancora identitaria) di dare soluzione (ri-fare il corpo, ri-fare la vita) a quella lacerazione. Ha scoperto un nucleo di angoscia (perturbante) che non si lascia rappresentare, pensare, padroneggiare. Artioli nota come anche «l’Artaud messicano, che esalta la natura come un serbatoio di forze vive, è costretto ad ammettere l’esistenza di un nucleo recalcitrante ed ex lege, una porzione di disessere sedimentata nel cuore delle cose».[68]
Rifiuta, o non trova, l’impersonalità nell’altro senso, verso l’alto e nell’Altro; partendo dal presupposto della originaria unità non può accettare di risalire (la via del ritorno) e di cercare nel linguaggio stesso, nei sistemi simbolici, quel valore che avrebbe sostenuto tale divisione. Artaud cerca questo Altro (il teatro balinese, la Qaballah, l’Alchimia, la Magia)…ma non gli funziona fino in fondo, forse perché non riesce a farne una tradizione, per insufficiente appropriazione; oppure perché parte dal presupposto sbagliato, dalla nostalgia di uno stato mitico unitario. I riferimenti ad altri saperi (antropologici, magico-esoterici, religiosi, psichedelici), diventano nel tempo utopie e nuove visioni che rinnovano (con il teatro balinese, alchemico, ermetico, magico) il tentativo di rendere sostenibile la lacerazione originaria. Allo stesso modo anche l’utopia del “corpo senza organi” sarà un risposta alla divisione del corpo e della coscienza.
Di fronte alla divisione soggettiva il corpo assume per Artaud una doppia valenza: da una parte è l’attestazione e la discesa nella lacerazione ma, dall’altra, si dispone come il territorio di una utopia irrealizzabile: quella, appunto, di un corpo senza organi.
Si vede come Artaud discenda a picco nella “Carne”, trovandovi il punto di scissione dalla volontà, dal pensiero, dall’emozione. Il punto estremo delle disidentificazioni, della spersonalizzazione e dell’impersonalità con un effetto di angoscia, di vuoto. Il corpo è inciso, lamellato dall’angoscia, scisso; il pensiero scava la sua inconsistenza, circoscrive il vuoto che lo risucchia. E affiora l’insopportabile sdoppiamento: si profila una dicotomia centrale, una doppia oscillazione. In basso, il sistema fusionale, la nebulosa, l’informe, il taglio; in alto, la lucidità differenziante, il corpo-mente cosciente e sentito. La ricerca dell’equilibrio impossibile come sintesi di opposti, è il ritorno a un’armonia primigenia, a una percezione globale della vita in cui l’essere si rivela indifferenziato. La nuova geologia mentale rivela gli strati più profondi, mostrando la lacerazione dolorosa, lo sdoppiamento, la divisione. Solo che per Artaud tale divisione non è costitutiva ma effetto perverso della civiltà, è degradazione dell’essere originario. Inizia l’opera di rifondazione dell’io, ucciso dalla civiltà e dal linguaggio.[69]
Non è così strano che Artaud giunga al limite della vita psichica e corporea proprio a partire dalla nostalgia per l’unità. La follia è credersi un’identità, ha affermato Lacan. Ma anche psichiatri illuminati come R. Laing sono caduti nell’equivoco dell’unità infranta. Laddove Laing sembra chiedersi: “come abbiamo fatto a uscire dal corpo. A separarci da noi stessi, a scindere l’io?”, Freud riconosce, invece, la divisione soggettiva come costitutiva. La questione è: “come facciamo a entrare nel corpo, a sentire e utilizzare questo corpo come proprio?”. La nostalgia per un corpo senza organi testimonierebbe proprio questa difficoltà di “entrare” in un corpo che sentiamo in parte estraneo, fatto di funzioni, di parti, di organi indipendenti dalla nostra volontà…. e di sentirlo come proprio, corrispondente alla nostra identità.
Per affrancarsi dagli automatismi biologici e culturali, dalle funzioni, dai bisogni e dalle malattie “organiche”, che vincolano la libertà, bisogna apprendere a “danzare alla rovescia” con un “corpo senza organi”.
Come hanno notato Deleuze e Guattari:
L’organismo non è per nulla il corpo, il corpo senza organi (CsO), ma uno strato sul CsO, cioè un fenomeno di accumulazione, coagulazione, sedimentazione che gli impone delle forme, delle funzioni, dei collegamenti, delle organizzazioni dominanti e gerarchizzate, delle trascendenze organizzate per estrarne un lavoro utile” […]. L’organizzazione è l’articolazione, la congiunzione delle funzioni e delle membra e quindi la frammentazione, la differenziazione. In quanto tale costituisce lo smembramento del corpo proprio (Leib). La divisione del corpo in organi è necessaria alla struttura, ma ogni struttura in quanto articolazione analitica sfugge necessariamente al soggetto: la divisione del corpo in organi apre alla carenza, il corpo “si fa assente a se stesso, dando a intendere di essere, o credendo di essere, lo spirito. […] L’organo accoglie, dunque, la differenza di ciò che è estraneo nel mio corpo, è sempre l’organo della mia perdita e ciò è tanto originariamente vero che neppure il cuore, organo centrale della vita, o il sesso, organo primo della vita, sono in grado di sfuggirvi.[70]
Questo corpo paradossale, fatto di connessioni improbabili di ossa e di organi, Artaud lo smaschera, lo spezza moltiplicando le posture contraddittorie e le «definizioni opposte, allo scopo di renderlo insieme inconcepibile (in tutti i sensi del termine) e illeggibile (inconsumabile). Esso è nello stesso tempo corpo-corazza e corpo aperto, corpo-scorza e corpo scorticato, […] corpo chiodato senza interno e corpo pieno d’organi».[71]
Nel dare risposta al “come” rifare la vita attraverso il teatro, Artaud sembra fallire. Grotowski e Bene risponderanno scendendo nella Carne e toccando la divisione, il taglio, ma trovando anche il modo di risalire, di articolare l’impersonalità del bios con una impersonalità del valore, nel simbolico, nell’oltre-teatrale che ha funzionato come Altro (per Grotowski i saperi iniziatici tradizionali dell’Induismo, del Sufismo, ma anche attraverso Gurdijeff; per Bene il sapere poetico-letterario e il sapere analitico-filosofico di Heidegger, Lacan…).
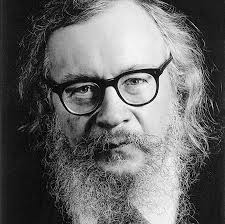 3. Questioni grotowskiane
3. Questioni grotowskiane
L’insieme io-corpo – una conciliazione impossibile per Artaud – è stato da Grotowski dislocato in una coscienza organica la cui peculiarità è di essere ‘impersonale’. Dal suo lavoro è emersa la prospettiva di una forma di coscienza che non ha bisogno di legare le emozioni all’io, quell’io che le rappresenta, mentre si riconosce attraverso di esse.
Negli anni del Teatro Povero, Grotowski indicava come tale qualità della coscienza possa essere raggiunta dal performer attraverso un atto di auto-penetrazione e denudamento, una sorta di psico-analisi che arriva al fondo dei processi personali e tocca lo strato impersonale, archetipico (non privato) del corpo-mente. In una lettera a Barba del 1963, scrive: «Credo che le ricerche di quest’ultimo periodo (auto-esplorazione, anatomia psichica, psico-analisi del “non privato”), se sviluppate, possano aprire possibilità e prospettive inesauribili. […] È una conoscenza assolutamente concreta che si può studiare e verificare sul proprio organismo».[72]
Per Grotowski la preparazione dell’attore deve tendere a: 1) stimolare un processo di auto-penetrazione, 2) permettere di disciplinare e convertire in segni tale processo, 3) eliminare le resistenze psico-fisiche. In particolare, su questo ultimo punto precisa come «la costruzione di una nuova personalità passa attraverso la decostruzione della vecchia: la realizzazione di questa individualità non avviene tramite l’apprendimento di cose nuove, ma piuttosto con la rimozione di vecchie abitudini».[73]
È la pratica della “via negativa” a condurre il performer verso la attualizzazione dell’esperienza stessa dell’impulso: «Prima di una piccola azione fisica c’è l’impulso […] l’impulso è una reazione che comincia sotto la pelle e che è visibile solo quando è già diventato una piccola azione. L’impulso è così complesso che non si può dire che appartenga solo alla sfera corporea»[74] e tuttavia l’azione fisica diventa radicata nel corpo soltanto quando comincia da un impulso, altrimenti è qualcosa di convenzionale simile al gesto.
3.1 L’ascolto
Nell’accento che Grotowski pone sullo stato di “ascolto”, si colgono le nuove direzioni che il training apriva alla esperienza del soggetto. Attraverso la via negativa come pratica di decostruzione (disidentificazioni, superamento di blocchi, abitudini e resistenze psico-fisiche) emerge una disposizione possibile alla passività, nella quale l’io, depotenziato, retrocede lasciando uno spazio aperto, ricettivo alle fluttuazioni impersonali. [75]
Dunque, nella “condizione di ascolto”, l’accesso ad un grado dell’esperienza che non si esaurisce nell’emozione né nello stato della coscienza, ma è il rendersi presenti alla coscienza degli andamenti elementari del sentire, quell’universo di modalità che pre-esiste all’emozione intesa come fatto e luogo di riversamento e riconoscimento dell’ io.
Sono queste modalità le matrici dell’“impulso”, che già Dewey[76] aveva indicato come elemento essenziale del sentire. Se la partitura creata dal performer è una sequenza di impulsi, di stati di presente, è l’ascolto la pre-condizione rispetto alla dinamica dei micro-andamenti psico-organici che accadono a prescindere dall’intenzione del performer. Micro-andamenti che non si identificano con i vissuti personali, con le emozioni o gli aggregati mnemonici, ma piuttosto ne costituiscono le qualità elementari che precedono ogni eventuale o possibile “modo” dell’esperienza.
La lettura dell’emozione performativa o meglio del “sentire performativo” offerta da Grotowski, sembra vicina alle acquisizioni di alcuni psicologi dell’età evolutiva, in particolare di Daniel Stern, in merito alla sintonizzazione emotiva e alla strutturazione dell’esperienza. Parlando di impulso, infatti, Grotowski ha guardato a quello stato della potenzialità organica, di per sé indivisa e inarticolata, che gli studi di Stern ci aiutano a definire “pre-categoriale” o “pre-modale”.
L’impulso psico-organico ha le sue radici, il suo luogo, in un grado della emozione, che non ha nulla di psicologico, personale, ma si lascia cogliere nella qualità pre-modale della esperienza o – nei termini dello psicoanalista W. Bion – nel sistema “protomentale”: uno stadio di avvenimenti «in cui il fisico e lo psicologico sono ancora indifferenziati»[77] È da questa matrice che hanno origine gli stati emotivi e le esperienze che saranno avvertite come “corporee” o “mentali”.
Anche la nozione di “pulsione” di Freud si colloca in questo campo indifferenziato. Fin dalla nascita esisterebbe una sorgente interna di stimoli che influenza e indirizza le dinamiche della mente; tali “spinte”, pulsioni, si trovano al confine fra la sfera psichica e quella somatica.[78] La pulsione è un concetto basato sulle nozioni di energia e struttura, dove non trova spazio una psicologia dei significati. Gli affetti vanno visti in funzione delle pulsioni, ne sarebbero un derivato (in conseguenza della formazione di oggetti e di rappresentazioni della pulsione).[79]
Rifacendoci alle ricerche della psicologia dell’età evolutiva, è possibile, in una lettura più articolata, ricondurre la nozione di “impersonale” a quei processi pre-emozionali che D. Stern ha chiamato “affetti vitali”, esperienze caratterizzate da qualità sfuggenti che vengono avvertite in termini dinamici, di movimento, di “energie” e corrispondono a esperienze quali: fluttuare, svanire, trascorrere, irrompere, vibrare, esplodere, crescendo, decrescendo, presenza, assenza, riempito, svuotato, forte, debole, denso, espellere, ritenere, espansione, contrazione, pulsazione ritmica… Gli “affetti vitali” non si riferiscono a un singolo canale sensoriale, sono bensì qualità comuni a tutte le modalità percettive, che tendiamo a tradurre da un canale all’altro: “percezione amodale”.[80] Tale capacità di ricevere l’informazione in una modalità sensoriale e tradurla in un’altra, rimane anche nell’adulto ed è alla base della percezione sinestesica, del pensiero analogico, poetico e metaforico. Rimane viva, cioè, una modalità del sentire che coglie le qualità più globali e transpecifiche dell’esperienza, in cui si sperimenta il mondo come un’unità amodale che varia solamente secondo le qualità generali dell’intensità, degli schemi temporali, delle configurazioni (che possono essere sia visive, che sonore, tattili, ecc.). Tali qualità primarie e amodali della percezione sarebbero la base del sentire.[81] «La filosofia, la psicologia e l’arte hanno da tempo definito intensità, tempo e forma, qualità amodali dell’esperienza (in termini psicologici) o qualità primarie dell’esperienza[82] (in termini filosofici)».[83]
“Amodale”, sia nel senso di protomentale che di precategoriale, richiama anche il campo dei processi primari e dell’inconscio, non inteso come luogo di contenuti rimossi e di affetti e modi inaccessibili ma, piuttosto, come luogo degli “insiemi infiniti”, non modalizzati. Per Woldron (Steps echology of the mind) l’inconscio cognitivo opera a un livello pre-modale riconoscendo prevalentemente non i contenuti o i modi, né la loro durata, ma solamente gli accessi al loro stesso cambiamento, riconosce le scansioni, i punti di passaggio, le rotture della continuità modale.
Il recupero della descrizione delle strutture precategoriali, ci permette di riaffrontare l’impersonalità grotowskiana dal lato delle emozioni: ciò che arriva come “autentico” (allo spettatore e al performer) non è il pattern riconosciuto e condiviso dell’emozione, ma i suoi andamenti costitutivi (sterniani), la cui attivazione (nel performer) ricade e si ricombina nello spettatore. Le emozioni non ci sono come sostanza, ma trascorrono e individuano delle relazioni nell’insieme precategoriale.
Tali pattern sono impersonali, svincolati dalle rappresentazioni dell’io e, per questo, sono capaci di trasmettersi se non trattenuti dalla volontà e dal giudizio.
Così le emozioni non sono costituenti prioritari, trascorrono nel performer, non lo trasformano in maniera definitiva perché non sono l’unico punto di attrazione obbligato per il soggetto.[84]
3.2 La coscienza trasparente
Penetrando sempre più a fondo nella rilettura novecentesca della improvvisazione, Grotowski ha riformulato i termini fondamentali del processo che individua il proprium del sentire performativo e, dalle condizioni dell’ascolto, lo ha condotto fino alle implicazioni più rarefatte .
In alcuni passi del saggio Il nuovo testamento del teatro, eliminati nella versione definitiva inclusa in Per un teatro povero, Grotowski scriveva: «per ottenere dall’attore che si “metta a nudo”, è necessario trovare in lui, o piuttosto rendergli possibile la scoperta in sé dei suoi motivi psicanalitici, della verità calma e dolorosa di se stesso. […] Se questo motivo è colto convenientemente, se vi si concentra tutta l’attenzione, esso non provoca un sentimento di esasperazione, ma piuttosto di “caldo” dolore, una sensazione simile a un grande mare tiepido».[85]
Una verità calda e dolorosa, un caldo dolore, un grande mare tiepido. La scoperta della verità calma e dolorosa di se stesso, attraverso il training e la via negativa «è la polla da cui sgorgano spontanei gli impulsi, senza bisogno di motivazioni esterne».[86]
Il compimento dell’atto in questione (auto-penetrazione, denudamento) comporta la mobilitazione di tutte le energie fisiche e spirituali dell’attore che si trova in un atteggiamento di risoluzione indolente, una disponibilità passiva che consente di realizzare una partitura attiva. È necessario ricorrere ad un linguaggio metaforico, e dire che in questo processo l’elemento determinante è l’umiltà, una predisposizione spirituale: non voler fare una data cosa, ma rinunziare a non farla; altrimenti l’eccesso diventerebbe sfrontatezza invece che sacrificio.[87].
Il processo deve prenderci. In questi momenti si deve essere interiormente passivi ma esteriormente attivi. La formula del limitarsi a “non fare” rappresenta uno sprone. […] Questa passività interiore fornisce all’attore l’occasione di venire preso.[88]
L’attore deve riuscire a denudarsi del proprio io e della volontà per poter ascoltare. Analogamente, abbiamo visto come per Heidegger il Dasein (l’esserci, l’essere aperto) è di natura passiva. La nozione di abbandono (Gelassenheit) è centrale in Heidegger e richiama la posizione di ascolto, di impersonalità. Una posizione che è al di là delle opposizioni interno/esterno, soggettivo/oggettivo, proprio perché apertura all’alterità del nostro essere; per questo, l’impersonalità è nel centro-vuoto del soggetto, al di qua e al di là dell’identità-io.
M – Perché non è in nostro potere risvegliare in noi stessi l’abbandono.
S – Altrove è dunque ciò che lo produce.
M – Non: lo produce, bensì: lo lascia-essere.
E – Certo io non so ancora cosa voglia dire il termine abbandono, ma presentisco vagamente che esso si risveglia quando il nostro essere (Wesen) è disposto (zugelassen ist) a lasciarsi ricondurre (sich einlassen) a ciò che non è un volere.
S – Lei parla continuamente di un “lasciare” (Lassen), cosicché può sorgere l’impressione che con ciò si intenda una sorta di passività. Credo invece di sapere che, quando parla di “lasciare”, quando parla di abbandono, Lei non intende affatto un debole lasciar correre, un lasciare andare le cose per il loro verso (ein kraftloses Gleiten-und Treibenlassen der Dinge).
E – Forse in questo lasciare, nell’abbandono (in der Gelassenheit) si cela un senso dell’agire ancora più elevato di quello che attraversa tutte le azioni del mondo e l’agitarsi dell’umantà…
M – un agire ancora più elevato che però non è affatto un’attività.
E – Perché l’abbandono non rientra affatto nell’ambito della volontà.
S – Passare dalla volontà all’abbandono mi sembra la cosa più difficile.[89]
Il tema della passività è qui inteso come disposizione di ascolto di “ciò che dorme”: esperienza di una passività più passiva della ricettività; passività che sfiora il nulla e mostra all’io la sua inconsistenza, in una pulsazione di apparizione-eclissi-apparizione-eclissi. In questo trascorrere, il “reale” prende posto nel soggetto. Nel, in un interno escluso, estraneo a me pur stando al centro di me (estimità). Il suo affiorare costringe a deporre ogni sfrontata pretesa di rappresentazione.
Nella coscienza ordinaria la consapevolezza è, per Grotowski, delimitata dagli oggetti interni; in tale stato si è ancorati a “questo” pensiero, a “questa” immagine, a “questa” emozione. Si può dire anche che ci si identifica con questi contenuti.
La progressiva dilatazione dell’io fino alla sua dissolvenza in una coscienza aperta, vuota, capace di comprendere gli aspetti inconsci, corrisponde nella terminologia di Grotowski alla “coscienza trasparente”.
In uno stato di coscienza trasparente, lo spazio interno è più ampio; diciamo che quando in genere una persona si trova in uno stato di coscienza simile comincia a percepire precisamente quello che succede dentro e comtemporaneamente fuori. Tutto ciò che si muove all’interno, l’agitazione delle emozioni, delle sensazioni, delle immagini, si può manifestare nel movimento, nella danza, ma al fondo si conserva un atteggiamento sereno, trasparente. Qui l’attore non attua una fuga dalla coscienza, ha reso la coscienza più vasta: la coscienza comincia a diventare spaziale, trasparente, i riflessi sono estremamente pronti e c’è qualcosa di luminoso che si intravede.[90]
3.3 Bios e Valore
La “via negativa” è un movimento di purificazione attraverso il quale l’io dell’attore, distoglie da sé il suo stesso corpo e le particolarità individuali per risalire a ciò che in lui è più di lui.
Si produce un continuo, doppio movimento. Verso l’ impersonalità attraverso il corpo, perché l’impulso con tutto il suo portato pre-categoriale, può solo radicarsi nelle energie del corpo e nell’azione: è il Bios, ciò che ci costituisce dal basso, nelle energie grossolane.
Ma più si scende nella carne più è necessario salire nell’artificialità, nel valore, nella disciplina, nella awareness: «più ci concentriamo in ciò che vi è di occulto in noi, nell’eccesso, nel denudamento, nell’auto-penetrazione, più rigida diventa la disciplina esteriore, cioè l’artificialità, l’ideogramma, il segno».[91]
Compito dell’attore è scendere nel buio dei meccanismi psico-fisici e salire nei grovigli delle matrici del linguaggio, del valore: le energie sottili nella terminologia grotowskiana.
Gli elementi in gioco nella de-costruzione pertengono al bios, la via negativa non può non passare attraverso il corpo. Attraverso di essi si innesca un processo in cui si perviene a micro-esperienze in grado di far intuire il livello impersonale e archetipale che a sua volta conduce a un orizzonte di riferimento (anch’esso impersonale, nel senso heideggeriano) che preesiste al soggetto e che alcuni hanno definito “valore”.
La condizione impersonale del soggetto non può che essere riferita alla dinamica continua che lega e tiene uniti “bios” e “valore” in quel movimento che Grotowski ha definito attraverso la metafora dell’ascensore: «Quando parlo dell’immagine dell’ascensore primordiale e dell’arte come veicolo, mi riferisco alla verticalità […], qualcosa che sta “sotto i nostri piedi” e qualcosa che sta “sopra la testa”. Tutto come una linea verticale, e questa verticalità deve essere tesa tra l’organicità e the awareness. Awareness, vuol dire la coscienza che non è legata al linguaggio (alla macchina per pensare), ma alla Presenza».[92]
I due estremi della verticalità sono anche richiamati dalla metafora energetica: energie grossolane, organiche, legate alla densità del corpo ed energie più sottili, legate alla consapevolezza e a un orizzonte di “valore”. «È come se cercassimo di entrare nella higher connection».[93]
Nell’impersonalità, sia del basso che dell’alto, l’attore è al di là della coincidenza corpo-mente. Non c’è più la volontà, il compito, la rappresentazione, la coscienza riflessiva, ma non c’è neppure il corpo. Nella trasparenza del corpo e della coscienza non c’è corpo-mente. C’è abbandono, c’è intervallo, vuoto.
Il nostro io si situa in una zona intermedia tra due zone d’ombra, impersonali, che si dispiegano al di sotto e al di sopra di essa: tra la vita silenziosa, magmatica e buia del nostro corpo e la vita silenziosa e indifferente dell’Altro che ci sovrasta.
Il valore, l’orizzonte etico-estetico, la tradizione, il linguaggio-segno hanno lo scopo di orientare il lavoro dell’attore verso l’alto, in una impersonalità “illuminata”, sottile. «Prima che una persona decida di fare qualcosa, deve elaborare un punto d’orientamento e poi agire in conformità e in modo coerente».[94] Questo non riesce ad Artaud, ma riesce a Grotowski e a Bene.
Come è possibile spogliarsi di tutto, toccare il grado zero delle identificazioni, delle maschere, e sostenere questo “vuoto” di forme, di emozioni, di identità? Artaud soccombe a questa invasione. Grotowski può sostenerla anche perché ha scisso il processo tra sé e Cieslak.
L’uomo ha sempre bisogno di un altro essere umano che possa realizzarlo in modo assoluto e comprenderlo. Ma ciò equivale in un certo senso ad amare l’Assoluto o l’Ideale, amare qualcuno che ti comprende, ma che non hai mai incontrato. Qualcuno che tu cerchi sempre. […] Quando l’attore comincia a lavorare stabilendo un contatto, a vivere in rapporto a qualcuno – non il compagno di scena, ma il compagno della sua vita – quando comincia a scrutare attraverso un’analisi gli impulsi del suo corpo, il rapporto di questo contatto, questo processo di scambio, avviene in lui sempre una rinascita.[95]
È lo stesso Grotowski a esplicitarlo: «la mia evoluzione è proiettata in lui, o meglio, è scoperta in lui, la nostra comune evoluzione diventa rivelazione. Questo non vuol dire formare un allievo ma semplicemente aprirsi ad un altro essere rendendo possibile il fenomeno di una “nascita condivisa e doppia”. L’attore nasce di nuovo – non solo come attore ma come uomo – e con lui io rinasco».[96]
In questo modo l’attore può realizzare l’“atto totale”: «È un atto grave e solenne di rivelazione. L’attore deve essere disposto a una sincerità assoluta. È come un passo verso l’apice dell’organismo dell’attore in cui la consapevolezza e l’istinto si congiungono».[97]
Tale condizione non ha a che fare con esperienze extra-ordinarie, con una temporanea modificazione dello stato di coscienza, bensì con un cambiamento nel “modo” di essere soggetto. In effetti, nelle diverse modalità di ritrazione dell’io e di decostruzione che Grotowski affronta nella pratica, si persegue non tanto un diverso “stato” di coscienza del performer ma un diverso “stadio” del soggetto, una vera e propria trasformazione (al punto che lo si dovrà qualificare come “attore santo”).
Non è un caso che molti principî e metodiche siano importate nel teatro novecentesco da discipline sapienziali: si pensi alle fonti cabalistiche di Artaud o agli influssi sapienziali Sufi che, attraverso Gurdjieff, influenzarono molti pedagoghi, registi teatrali e danzatori. È evidente il motivo che induceva questi scienziati del corpo-mente a rivolgersi verso saperi tradizionali e discipline spirituali: qui, più che in qualunque scienza dell’uomo, si perseguiva la modificazione, l’addestramento, lo smontaggio dell’identità-io (corpo, pensiero, emozioni, bisogni, motivazioni…) e la messa in prospettiva del soggetto vuoto.[98]
3.4 La modalizzazione del soggetto
Grotowski ha colto le condizioni del sentire performativo che sottintendono un diverso ordine di considerazione del soggetto. Muovendo, ad esempio, da una diversa articolazione tra l’essere attivo e l’essere passivo – quello stadio personale che Grotowski ha definito la “disponibilità passiva ad una partitura attiva” (attivo cum passivo)- ha indicato un diverso posizionamento dell’io in relazione alla totalità del soggetto.
Nella sua prospettiva possiamo riconoscere almeno tre elementi portanti: il soggetto non è dato come coincidente con l’io attivo, non è collocato positivisticamente nell’opposizione tra io e non-io, l’io non è dato neppure come parte prevalente del soggetto.[99]
Il recupero della descrizione delle strutture precategoriali, ci permette di affrontare l’impersonalità grotowskiana dal lato delle emozioni: ciò che arriva come “autentico” (allo spettatore e al performer) non è il pattern riconosciuto e condiviso dell’emozione, ma i suoi andamenti costitutivi (sterniani), la cui attivazione (nel performer) ricade nello spettatore e qui si ricombina. Le emozioni non si danno come sostanza, ma trascorrono e individuano delle relazioni, nei pattern precategoriali.
Tali pattern sono impersonali, svincolati dalle rappresentazioni dell’io e, per questo, sono capaci di trasmettersi in quanto non frenati (trattenuti) dalla volontà (di autenticità o efficacia) dell’io.
In tale riconoscimento del fondamento impersonale dell’esperienza, troviamo non solo un superamento della nozione dell’io, ma anche della nozione postmoderna di decentramento, di moltiplicazione, di decostruzione e di liminalità.
Dalla sua ricerca intorno alla organicità creativa è emersa, infatti, la possibilità di intravedere, più che uno “stato discreto” dell’io, una “condizione” o stadio del soggetto che non può essere costretto nei confini di una “esperienza non ordinaria”, ma è frutto di uno sguardo “sincronico” e, come il pre-modale, è un fenomeno che accompagna il soggetto nel tempo. Una condizione legata alla durata del soggetto stesso, una trasformazione che non si restringe al tempo della rappresentazione ma, al contrario, va a formare una delle basi su cui si erige la negazione dell’istanza di rappresentazione.
È stato uno spostamento di prospettiva che ha messo in evidenza fino a che punto il centro del problema del sentire performativo non è il rapporto io-emozione ma la condizione del soggetto che di quel binomio è il contentitore. Grotowski, ha lavorato intorno alle possibilità di riconoscere quella condizione senza, per altro, limitarla allo statuto della rappresentazione.
Questa particolare condizione del soggetto, può, oggi, essere considerata un proprium del sentire performativo. Parafrasando la formula buddhista di “via di mezzo”[100] parleremo di “soggetto di mezzo” in quanto condizione che trascende i dualismi e nello stesso tempo li contiene.
Abbiamo visto come le acquisizioni grotowskiane relative all’esperienza performativa, convergono nell’illustrare una posizione in cui il «performer appare più come una componente dell’azione, quasi uno strumento per la sua realizzazione, che come un soggetto attivo».[101] Una condizione questa che non può essere spiegata solo dalla tradizionale opposizione tra attivo e passivo, ma richiede una elaborazione più sottile, capace di introdurre una differente articolazione delle diverse “modalizzazioni” del soggetto.[102]
Abbiamo a che fare con una condizione descritta nella grammatica greca con la nozione di diathesis, che indica “attitudine, stato della mente” e, dunque, un particolare modo di essere del soggetto nella esperienza.[103] Un particolare modo di essere, né attivo né passivo, era previsto nella grammatica dalla voce media (mesòtes). Oltre alle due voci base di “attivo” e “passivo”, la voce “media” è una terza forma, generalmente descritta come forma passiva con un significato attivo.
«Secondo Benveniste, l’attivo denota un processo che si realizza al di fuori del soggetto ed esprime esteriorità all’azione, mentre nella voce media il processo ha luogo all’interno del soggetto, che a sua volta è interno all’azione del verbo […]. La principale caratteristica della voce media è di definire la posizione del soggetto come “interno” al processo in corso».[104] Nelle lingue indoeuropee, “essere”, così come “andare” o “fluire” sono verbi attivi in quanto non richiedono la partecipazione del soggetto. Nella voce media, al contrario, il soggetto è interno al processo, realizza qualcosa che è realizzato soltanto in sé e attraverso di sé; tipici esempi dei verbi della voce di mezzo, sono ad esempio: “dormire”, “giacere”, “immaginare”, “crescere” e così via.
Qualcosa di analogo aveva segnalato Barthes in riferimento alla scrittura: «Nel caso della voce media, il soggetto modifica (affects) se stesso nell’azione: egli rimane sempre all’interno dell’azione anche se questa coinvolge un oggetto».[105]
La voce media indica «quelle azioni informate da un senso elevato del sé da parte del soggetto che le esegue».[106] Costitutisce l’agente (l’attore) per mezzo dell’azione.
La voce media ci aiuta a identificare una posizione del soggetto, a cui la nostra grammatica ci ha disabituato, e lo mostra in una posizione che possiamo definire come una “modalizzazione” non riducibile allo stato attivo, passivo, oppure emozionato, intenzionale.
“Soggetto di mezzo” non coincide con uno stato liminale[107] o uno stato transizionale: è una “condizione” del soggetto, non uno “stato discreto”. Una condizione che non è un contenuto, non è uno stato transitorio, non è un cambiamento di coscienza né l’accesso ad esso, è piuttosto una posizione che sta prima e al di là di ogni processo del sentire. “Soggetto di mezzo” è una modalizzazione del soggetto in una condizione che sta prima delle emozioni e oltre le emozioni, in grado di includerle e di farsi modificare da esse ma non identificando in ognuna di esse la propria verità.[108]
Parliamo di una modalizzazione avvenuta nel continuum di una pratica incessante, nella quale l’esperienza stessa non è più una categoria o un contenuto.
Il modo per riconoscere e descrivere il soggetto di mezzo, infatti, ha a che fare con un altro “tipo logico” (contesto) nel quale le strutture pre-categoriali dell’esperienza offrono la possibilità di edificare una soggettività che include quelle categorie e quelle oscillazioni, ma le mette in prospettiva. Il “valore” predittivo di ognuna di quelle strutture viene riscoperto alla luce di un percorso formativo e/o rivelativo in grado di riconoscerne l’impersonalità, non solo sul piano dell’io ma anche sul piano culturale e addirittura ontologico (il lavoro con l’impulso o con il respiro e con le azioni fisiche, diventa un modo per riconoscere il funzionamento universale del corpo-mente all’interno di una cultura o tradizione già data e indipendente dall’io). In ciò l’apertura verso le tradizioni sapienziali appare frequente e quasi ineludibile.
 4. Carmelo Bene: sottrazione ed eccedenza
4. Carmelo Bene: sottrazione ed eccedenza
L’esperienza artistica di Carmelo Bene attraversa tutte le questioni che finora abbiamo posto come pertinenti al mutare dell’indagine intorno al sentire performativo. Nel suo incarnare la divisione e l’oltrepassamento dell’identità (del corpo, della mente, delle emozioni), Bene è in risonanza con Artaud, con la sua retrocessione verso lo smembramento, ma non si lascia sedurre dalla nostalgia dell’unità. Come lui stesso ha sottolineato: «La parola prima delle parole, nello smembramento del corpo in Antonin Artaud, è lacerazione ossessiva e inconsolabile rimpianto d’unità originaria».[109] La sua, invece, è sì una regressione verso il “deserto delle forme”, verso lo strato impersonale del corpo e dell’identità, ma una regressione “festosa”, parodistica e rassegnata alla condizione di automatismo e di disessere che la “macchina attoriale” mette in atto.[110] Attraverso una ricerca sui “guasti” del linguaggio annienta ogni connivenza tra mente, spirito e corpo «[…] senza nostalgie eliogabaliche d’unità “originaria” […]. Tutto è agrafia-afasia».[111]
Se Bene opera un rifiuto del linguaggio e della convenzione, frantumando prima di tutto lo statuto di io e identità dell’attore, non è per ri-farsi un nuovo corpo (più originario o armonico), né per cercare un “uomo nuovo”. L’opera di decostruzione non si proietta oltre il teatro, nella vita, poiché la vita oltre non c’è.[112] In questo radicale e festoso annientamento di sé e della vita, Bene radicalizza anche la questione della via negativa di Grotowski.
Eppure, l’attore non svanisce, rimane sulla scena, vive, evoca, incide emozioni, suscita violente reazioni, fa apparire una nuova condizione di essere… nella mancanza-ad-essere.
Tale condizione acquista nello stesso Bene, intelligibilità specchiandosi in un orizzonte culturale che comprende oltre alle figure della poesia romantica e simbolista francese, anche figure come Heidegger e Lacan. Ed è, a nostro avviso, attraverso questi riferimenti “forti” che Bene può costruirsi un orizzonte di “valore” che gli permette di mettere in prospettiva il lavoro di sottrazione, di smontaggio e di sostenere la posizione svuotata e lacerata dalla quale Artaud voleva espatriare e guarire.
L’attore deve abitare il prima e il dopo della rappresentazione, una terra di nessuno (né del personaggio, né dell’io), una terra deserta, vuota. Deleuze ha parlato di una terra di mezzo, ma «il mezzo non è una media, è invece un eccesso. […] Non è né lo storico, né l’eterno, ma l’intempestivo».[113] È la lotta del soggetto per svincolarsi dalla Storia, per uscire dal mondano. Sta al di qua e al di là dei costrutti personali e culturali.
AL DI QUA sta l’estetica della sottrazione, in cui si ritirano tutti gli elementi stabili, invarianti, identitari «tutto quanto costituisce elemento di potere, nella lingua e nei gesti, nella rappresentazione e nel rappresentato. E non si può nemmeno dire che sia un’operazione negativa in quanto dà inizio e mette già in moto tanti processi positivi»[114]
AL DI LÀ sta l’estetica dell’eccesso, in cui la mancanza produce un effetto di “realtà” inaspettato e perturbante che si da come un al di là del piacere/dispiacere, un troppo di affetto non riconoscibile e non riconducibile a un io.
4.1 Io è un altro: la mancanza-ad-essere della macchina attoriale
Uscire dal teatro di rappresentazion[115] pur rimanendo sulla scena, presuppone, per Bene, un’operazione in grado di annunciare “altro”, che non è l’altro come personaggio rispetto a un io dell’attore. Per Bene non esiste l’Io dell’attore: ça manque. Ed è proprio “nel bel mezzo del vuoto che noi siamo”, in questa mancanza originaria[116] che si annuncia altro. «Nel teatro del non-rappresentabile, l’Attore è infinito. […] È l’infinito della mancanza di sé».[117]
Come ha sottolineato M. Grande:
In Carmelo Bene la questione del soggetto[118] è la domanda fondamentale che tocca la differenza insormontabile tra essere e rappresentare, tra immagine dell’Altro[119] nella voce (e nel linguaggio) e radicamento del soggetto nella phoné. La polemica contro la rappresentazione concerne innanzi tutto la denuncia e il rifiuto di un teatro di riproduzione dei “ruoli dell’Io” a scapito del soggetto. […] La parola dell’attore non rappresenta né riproduce le vicende dell’Io. Presenta sulla scena dell’Io (il teatro borghese di rappresentazione) il più irriducibile affronto alla “consolazione dell’identità” che mai sia stato tentato all’interno del teatro.[120] La tanto invocata coerenza, integrazione tra corpo e mente, è da Bene denunciata come la misera chimera dell’identità, una patetica nostalgia dell’Io, in lui il «teatrino dell’Io frantuma».[121]
La partitura dell’Io lirico in Carmelo Bene annuncia e pratica la dissociazione fra Soggetto e Io: il soggetto come flusso esistenziale e come partitura narcisistica dell’attore scagliato in un gesto demònico di onnipotenza contro l’identità del personaggio e la vanagloria psicologica e sociale dell’Io. […] Il senso della operazione era scandito teoricamente dall’emergere del corpo e della voce, delle “materie teatrali” come impedimento del personaggio e intralcio dell’Io. Materia teatrale e sostanza dello spettacolo diventava, così, il lavoro dell’attore, nel suo farsi soggetto-scena svincolato da quell’Ego di servizio che è l’identità (psicologica, sociale, storica).[122]
Affermazioni come “non esisto: dunque sono” o “io è un altro” non sono, in Bene, delle provocazioni o dei giochi di parole ma enunciati precisi che spiazzano ogni possibile indizio di identificazione, non sono neppure una condizione dell’attore che si sdoppia o si proietta in una alterità, ma dicono letteralmente la verità della fondamentale mancanza-ad-essere della macchina attoriale, mancanza che s’affaccia «solo in chi s’è davvero purificato dal peccato dell’identità».[123]
Era stato Lacan a riprendere la formula di Rimbaud “io è un altro” per suggerire la divisione del soggetto, che differisce da sé stesso (l’identità, l’immagine di sé, l’io) manifestandosi in rapporto con l’alterità interna al soggetto stesso. La concezione del “soggetto diviso” si rifà a una prospettiva che vede tale divisione costitutiva, originaria dell’essere umano in quanto immerso nel linguaggio.[124]
Bene non è un io diviso, tormentato, schizofrenico, delirante. «Al contrario è un non-io, un recitante fornito solo della sua realtà esteriore, un attore che è ciò che finge di essere. Tutto ciò consapevolmente[125], esplicitamente».[126] Non è semplicemente un io diviso, un attore che “è ciò che finge di essere”, che si assume la responsabilità della sua inconsistente identità e della sua “mancanza-ad-essere”. In lui non c’è sdoppiamento, non c’è personaggio in cui trasferirsi né luogo a cui tornare (l’io). Il personaggio non è più separato dall’attore, ma assorbito in esso. «Non più l’attore che “entra” nel personaggio, ma il personaggio che “devasta” l’attore».[127] Ciò produce una diversa posizione dell’attore: non più io-psicologico ma soggetto-lirico che si manifesta proprio (e solamente) nello stare in scena. Una scena in cui si esibisce un soggetto privo di memoria, volontà, controllo del reale: esposizione lirica del “soggetto nudo”, «il soggetto si fa lago esistenziale, Io lirico».[128]
4.2 Gli affetti modalizzati e la phoné
«Deconcettualizzato tutto, liquidato veramente il pensiero, recuperato lo spirito della musicalità e non della musica, la finzione viene soppiantata. Gli affetti, come dice Deleuze, diventano modi; le emozioni cioè corrispondenti, si fanno modi vocali; questo, che è di un’importanza fondamentale, non fa certo allievi. “Basta appena a (dis)fare se stessi”».[129]
Il suo amico e musicista degli ultimi anni, G. Luporini, ricordando le loro conversazioni: «Mi parlava di “modalità” degli affetti, non in quanto espressi in una recitazione dell’io psicologico, ma in quanto sottratti a esso e intuiti e detti in una dimensione arcaica, metastorica e a-psicologica».[130] E lo stesso Bene in Proposte per il teatro, associa il “modo” all’“emozione”, all’andamento, al motus, al movimento, ovvero alla modificazione, lasciando cadere del tutto l’aspetto del contenuto (il “cosa”) e dell’identità (il “chi”): «D’accordo, conta il “come”. Io vò significando il “come”. Dunque “modo”. Significare un “modo” = modificar».[131] E ancora: «sfida e vittoria del modale dove appunto (e, guarda caso, affetti si dicevano i modi musicali nel tempo andato) gli affetti diventano modi».[132]
Deleuze ribadisce che «Nella variazione contano i rapporti di velocità e di lentezza e la modificazione di tali rapporti, in quanto trascinano i gesti e gli enunciati, secondo coefficienti variabili, lungo una linea di trasformazione. […] Solo affetti e niente sentimenti, niente soggetto, solo velocità e niente forma».[133] E Bene, “sottoscrivendo” Deleuze, riprende:
Non basta proporre una nuova rappresentazione del movimento, dacché la rappresentazione è già mediazione. Si tratta invece di produrre nell’opera un movimento capace di smuovere lo spirito al di fuori di ogni rappresentazione, e di fare dello stesso movimento un’opera che escluda l’interposizione, di sostituire dei segni diretti a rappresentazioni mediate, d’inventare vibrazioni, rotazioni, vortici, gravitazioni, danze o salti che tocchino direttamente lo spirito.[134]
La phoné è lo strumento per fare tutto ciò, per smuovere e attivare le vibrazioni, i nuclei protomentali e arrivare direttamente a toccare l’interno dello spettatore, senza rappresentazioni o forme codificate (linguaggio). La comunicazione tra attore e spettatore procede da un dentro a un dentro, da un impersonale a un impersonale, da inconscio a inconscio. «L’invenzione di una voce modalizzata […] esalta il dentro, ed invece di estrarlo, di tirarlo fuori, lo destina ad un altro dentro».[135] La phoné «consente a un interno di trasferirsi in un altro interno, recidendo il filo della comunicazione. Un dentro “soffia” in un altro dentro, demònicamente immediato. E la voce stessa si ascolta dire, La voce è la sua stessa eco»[136]
È un movimento capace di far emergere un mondo di materie sensoriali, di superfici fluide, di sensibilità diffuse, non riconducibili a categorie emozionali ma semmai a «quei vissuti inintenzionali che Husserl chiamava “mormorio” o “farfugliamento”: il mondo come rumore sensoriale».[137] L’inconscio parla e lo fa essenzialmente attraverso la voce, non ancora parola, comunicazione, ma nuda espressione pulsionale. È lo stesso Bene a ribadire il fondamento pulsionale del soggetto al quale l’Io non ha accesso (né come coscienza né come volontà) e che trova la sua dis-continuità nel dominio del significante-voce: «Così come subiamo passivamente ogni nostra percezione prenatale, subiremo anche in seguito il significante. Nella recidività della vita, il discorso non apparterrà mai all’essere parlante».[138] Anche la voce si subisce passivamente, come significante inintenzionale.
Alla serie degli oggetti pulsionali[139] descritti dalla teoria analitica: le feci, il seno, il fallo, il flusso urinario, Lacan aggiunge la voce, il niente e lo sguardo. Non è certo indifferente questa aggiunta, alla luce della pratica di Bene che proprio nella voce-pulsione trova la tana del suo essere soggetto mancante, inafferrabile, unico.
In questo senso il legame voce-soggettività[140] è essenziale: la voce non come strumento espressivo (di un io) ma come condizione-pulsione del soggetto-diviso. È nella phonè che si pratica la dissociazione estetica, mentale, emozionale fra soggetto e Io, fra parola-suono e parola-significato, fra voce-pulsione e discorso-linguaggio. La voce come phonè mette fuori gioco l’istanza di rappresentazione e si fa habitat della mancanza-ad-essere dell’attore: «nella phonè il soggetto è sempre e comunque in gioco, un gioco di perdite e di assenze che negano alla voce lo statuto di protesi dell’Io».[141]
4.3 Lacan-Bene e il reale esorbitante
Nel Seminario I, Lacan a commento di un caso clinico afferma: «Questo giovane soggetto è per intero nella realtà (dans la réalité) allo stato puro, non organizzato. È interamente nell’indifferenziato».[142] E più avanti: «Prima della parola nulla è, né non è. […] È con la dimensione della parola che la verità si scava nel reale […]. La parola introduce il vuoto dell’essere nella tessitura del reale (dans la texture du réel)».[143]
La tessitura del reale è piena, compatta, senza fessure, è il Tutto. Affinché il soggetto avvenga si deve produrre un taglio, una faglia, un buco, una differenza, una articolazione. Ecco perché, normalmente, siamo lontani dal reale, immersi nel linguaggio e nell’articolazione; per sperimentare il reale dobbiamo necessariamente toccare l’indifferenziato, qualcosa che sta prima della parola, un luogo in cui “nulla è, né non è”, là dove il niente (rien) non è opposto all’essere, si fa esperienza del “reale”.
Il linguaggio, se da un lato uccide la “cosa”, strappa all’essere la sua realtà piena scavando un buco, una mancanza, una lacerazione, dall’altra parte è il Linguaggio stesso a dare all’essere la sua apparizione e il suo proprium: a partire da quella mancanza l’essere umano risale grazie al linguaggio non più verso una originaria pienezza e coincidenza col reale e col Tutto, ma verso un’eccedenza che Lacan qualifica come “godimento”. È il linguaggio ad annullare il rapporto diretto con il reale-tutto, ma è il linguaggio a fondare il propriamente umano, il plus-valore e il plus-piacere che è il godimento. Senza linguaggio niente pulsione solo istinti, niente estasi solo sessualità. Il linguaggio nella sua letteralità significante fa emergere il soggetto del godimento. Il significante puro ritaglia il reale e rende possibile esperirlo, altrimenti sarebbe la frammentazione e angoscia (l’esperienza di Artaud). Il significante è la causa del soggetto, e inevitabilmente lo costituisce diviso, in quanto effetto di linguaggio…La phoné per Bene e l’impulso per Grotowski sarebbero i significanti puri che mettono a contatto con il reale (réel), indifferenziato, prelinguistico, premodale. Accettando la mediazione del significante, il reale può essere toccato evitando l’angoscia, ci si può abbandonare ad esso, si può sostare nella radura dove l’ente coglie l’Essere, con un effetto di eccedenza, di “godimento”. Così, il Linguaggio è responsabile della mancanza (visto dal basso) e della eccedenza (visto dall’alto). L’esperienza, diventa la congiunzione di due movimenti: verso il basso (sottrattivo) e verso l’alto (eccedente), effetto di mancanza da un lato e produzione di un supplemento dall’altro.[144] Così, nella esperienza di Bene, accanto alla ritrazione di qualsiasi istanza dell’Io troviamo l’eccedenza della soggettività lirica della phonè. «Per un attimo. Estromessi dalla godibilità del vuoto, dalla felicità sempre invivibile».[145]
Questa ascesi non ha nulla di triste o di puritano. Al contrario, è la condizione della gioia, del vero godimento che il teatro può far vivere, foss’anche al limite della crudeltà. Perché dietro lo spettacolo e le sue piccole soddisfazioni masturbatorie, è occultato ciò che costituisce il grande pericolo per le masse mediatizzate e il mondo globalizzato: l’incontro con il reale esorbitante. Questo incontro, come sanno tutti coloro che hanno assistito a uno spettacolo o a una lettura di Bene, è una lacerazione. Ma che vi proietta dall’altra parte, là dove la vita è a nudo, caotica, violenta, terribile e sublime. E questa lacerazione era l’effetto fisico della sua voce che spopolava il corpo e disertava lo spazio. Tutto il teatro si produce ‘a livello dell’audizione’, diceva Lacan. E, secondo Artaud, la funzione dell’attore è quella di trasferire dei corpi attraverso la potenza del suo timbro, di un grido, di un soffio che forzi l’organismo a liberarsi per lasciar passare la vita imprigionata in un’anatomia morbosa e moribonda.[146]
C’è un godimento del corpo che è al di là della sessualità, e della stessa esperienza dell’io: «[…] c’è un godimento al di là del principio di piacere».[147] Un godimento di cui egli stesso non sa niente, se non che lo prova. È il godimento dei mistici ed ha la cifra di un godimento propriamente femminile, supplementare: «Io credo al godimento della donna in quanto esso è in più. […] Questo godimento che si prova e di cui non si sa nulla, non è forse quello che ci mette sulla via dell’ex-sistenza?».[148]
Conclusione
Il teatro, nel secolo scorso, si è spesso lasciato investire dagli interrogativi posti dalle altre discipline. In molti casi quegli interrogativi sono stati parte della sua prospettiva e verificati dall’interno della sua stessa ricerca. Ma, sullo sfondo di quelle verifiche, restava sempre un problema ineludibile con cui occorreva fare i conti: la verità della emozione. Quella che abbiamo seguito finora è la traccia di una strada che, nel Novecento, ha fatto emergere il proprium del “sentire performativo” in quanto condizione che investe direttamente la posizione del soggetto prima ancora dei contenuti emozionali dell’io. Il lavoro di rifondazione del teatro, intrapreso dalla pedagogia teatrale, si è inoltrato nei processi che lentamente portano il soggetto a svincolarsi dalla padronanza dell’io e ad affacciarsi sul vuoto che lo costituisce. Alcuni sono andati anche oltre, fino al punto di prefigurare, per il performer, degli orizzonti di “valore” (sapienziale per Grotowski, filosofico-poetico per Bene) che costituivano allo stesso tempo le condizioni e gli esiti di quei processi. Al di fuori di quella pedagogia, Carmelo Bene ha incarnato un attore che riassorbe e fa implodere, nell’atto totale dell’arte-vita, i processi che altri hanno proiettato nella pedagogia. Se Grotowski, nella prassi teatrale, ha portato il performer fino alle più decisive conseguenze della “impersonalità”, Carmelo Bene si è fatto pienamente testimone, pur restando sulla scena, della rinuncia all’identità e alla rappresentazione.[149] Ad un primo livello, gli snodi del pensiero teatrale novecentesco, che abbiamo ricordato, possono essere considerati parte di quell’istanza decostruttiva che il secolo scorso ha posto con tanta urgenza; ma, ad un altro livello, dobbiamo riconoscere che essi hanno messo il teatro di fronte alla possibilità di un orizzonte di “valore” che, nel suo legame inscindibile con il “bios” dell’attore, predispone al cambiamento della condizione del soggetto. Abbiamo voluto mettere in luce i graduali mutamenti che hanno investito il rapporto tra emozioni e sentire performativo, quasi una lenta rivoluzione che, nel Novecento, si dispiega fino a giungere alle estreme declinazioni che ne ha dato Carmelo Bene. Muovendoci nell’ottica del performer abbiamo incontrato la progressiva evanescenza del problema stesso dell’emozione, che, così come era stato annunciato nella questione della desoggettivazione del sentire estetico, si delinea sempre più come una delle istanze meno pertinenti per l’attore. L’emozione, come abbiamo visto, non è la chiave che porta al riconoscimento della particolare natura del sentire performativo: la principale chiave di pertinenza risiede nella condizione della soggettività, o meglio nella posizione del soggetto che sta prima, intorno e oltre i contenuti emozionali.
NOTE
[1] M. Perniola, L’estetica del Novecento, Il Mulino, Bologna, 1997, cit. pp. 154-55.
[2] In questa prospettiva, il linguaggio non è affatto l’espressione di un soggetto che esiste anteriormente e indipendentemente da esso. Non siamo noi che abbiamo il linguaggio, bensì è il linguaggio che ha noi! …. Esso ci costituisce separandoci dall’indifferenziato, consegnandoci a un bordo che è il confine dell’essere.
[3] M. Perniola, L’estetica del Novecento, Il Mulino, Bologna, 1997, cit. pp. 162-164.
[4] Come ha sottolineato J. Derrida in La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino, 1999.
[5] «L’io si costituisce tramite identificazioni successive prodotte dalle immagini ideali del proprio simile. L’io, composto da questa serie di identificazioni, è il risultato di questo procedimento identificatorio in cui si aliena» (A. Di Ciaccia e M. Recalcati, Jaques Lacan, Bruno Mondadori, Milano, 2000, cit. p. 129). Identificandosi l’io si racchiude credendosi autosufficiente, padrone… solamente l’apertura all’inconscio, l’ascolto della intima estraneità è in grado di rompere l’infatuazione identitaria.
[6] M. Perniola, L’estetica del Novecento, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 160-161. Ne Il perturbante, Freud «osserva che l’estetica preferisce occuparsi di argomenti che corrispondono a stati d’animo positivi, quali il bello e il sublime: essa restringe così l’ambito dei suoi interessi che dovrebbero estendersi anche a quegli aspetti del sentire che sono caratterizzati da moti d’animo negativi, come appunto nel caso del perturbante (das Unheimliche). Questo potrebbe essere definito come quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare. Il perturbante dunque non può essere identificato con il “completamente altro”, l’assolutamente differente, perché ci è in qualche modo già noto e addirittura in qualche modo consueto e prossimo» (ibidem).
[7] J. Derrida, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino, 1999.
[8] «Il fatto fondamentale apportatoci dall’analisi è che l’ego è una configurazione immaginaria. […] Se l’ego è una funzione immaginaria, non si confonde col soggetto» (J. Lacan, Il seminario. Libro I. Gli scritti teorici di Freud, 1953-1954, Einaudi, Torino, 1978, p. 241).
[9] A. Di Ciaccia e M. Recalcati, Jaques Lacan, Bruno Mondadori, Milano, 2000, cit. p. 9.
[10] J. Lacan, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud (1953.1954), Einaudi, Torino, 1978, cit. p. 287. Per Lacan, la cifra fondamentale del folle è quella di “credersi un io”.
[11] «La promozione della coscienza come essenziale al soggetto nella sequela storica del cogito cartesiano, per noi è l’ingannevole accentuazione della trasparenza di Io in atto a spese dell’opacità del significante che lo determina» (J. Lacan, Scritti, Einaudi, Torino, 1974, p. 812).
[12] Lacan afferma l’autonomia e la supremazia del significante sul significato. Il significante è dato dal valore fonetico, materiale, primario del linguaggio. Ed è proprio la catena significante che individua il soggetto come separato dal significato, dal senso, dall’Io (vedi A. Di Ciaccia, M. Recalcati, Jaques Lacan, pp. 54-55; J. Lacan, Scritti, pp. 822-23).
[13] Cfr. F. Salvarezza, La realtà e la sua ombra: Lévinas, Lacan e la fenomenologia, in “La Psicoanalisi”, Astrolabio, Roma, 2004, n. 36, p. 181.
[14] J. Lacan, Scritti, cit. p. 652.
[15] Reale→linguaggio→mancanza→desiderio→soggetto→verità. Il reale è l’indifferenziato, nel quale il soggetto non verrebbe in essere se non fosse che il significante viene a scavare una faglia producendo una divisione, una mancanza nel reale. Da questa mancanza può emergere il soggetto – in quanto desiderio – che solo in ragione di quella mancanza trova la sua giustificazione. Per questo la verità del soggetto va cercata non nel reale ma nel significante e nel desiderio. Cfr. anche D. Tarizzo, Il desiderio dell’interpretazione. Lacan e la questione dell’essere, La Città del Sole, Napoli, 1998.
[16] Il desiderio è impersonale sia in quanto bisogno, appetito vitale, sia in quanto desiderare il desiderio dell’altro.
[17] F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano, 1977, cit. p. 40. Cfr. ivi, pp. 45, 145-146.
[18] J. A. Miller, Gli affetti nell’esperienza analitica, in “La psicoanalisi”, Astrolabio, Roma, 1990, n. 8, cit. p.139.
[19] Tale concezione si è generata proprio nel cuore di quella prospettiva, la fenomenologia, che verrà interpretata, fino ai giorni nostri, a rovescio, cioè come filosofia che riconduce l’esperienza alla coscienza, al vissuto, alla percezione, all’io. Prospettiva che viene assunta spesso come dimostrazione della presenza del soggetto a se stesso grazie al corpo, all’integrazione corpo-mente e alla percezione immediata dei dati dell’esperienza. Mentre, la fenomenologia, reagendo alle false alternative dualiste ereditate dall’impresa cartesiana tra la cosa e l’idea, l’oggetto e il soggetto, la natura e lo spirito ecc., è stata, al tempo stesso, uno sforzo teso verso un livello dell’esperienza anteriore a questi dualismi e verso una nozione di corporeità intesa come integrazione corpo mente o natura cultura, mostrando lo sconfinamento nell’ulteriorità di ogni possibile forma di collimazione.
[20] A. Zenoni, Fuori corpo e anima, in “La psicoanalisi”, Astrolabio, Roma, 2000, n. 28, cit. p. 271.
[21] R. Oliva, L’Io impossibile: la frantumazione del soggetto nell’opera di Samuel Beckett, in AA.VV., L’Io a più dimensioni, Red Edizioni, Como, 1989, cit. p. 132.
[22] Cfr. G. Agamben, Il linguaggio e la morte, Einaudi, Torino, 1982. Anche M. Perniola sottolinea che «la grandezza e la potenza del linguaggio poetico nei confronti dell’esperienza vissuta sta proprio nel fatto che la poesia porta in se stessa l’essere non meno del non-essere, la salvezza non meno della rovina, mentre l’esperienza vissuta è l’affermazione oltranzista e reattiva di una identità» (L’estetica…. cit. p. 163).
[23] L’inconscio non è il luogo più interno della psiche, la nicchia inviolabile dell’interiorità; al contrario, è il luogo più esterno. Nell’inconscio il soggetto è esteriore a se stesso; è il luogo in cui non può coincidere con se stesso. Estimità è la più intima eccedenza: «quell’estremo dell’intimo che è al tempo stesso internità esclusa» J. Lacan, in “La Psicoanalisi” n.16, Astrolabio, Roma, 1994, cit. p. 21.
[24] La frase è contenuta in una lettera scritta il 15 maggio 1871, diventata poi una sorta di “manifesto” delle avanguardie poetiche del Novecento. Ne riportiamo un passo significativo: «Poiché Io è un altro. Se l’ottone si sveglia tromba, non è affatto colpa sua. Per me è evidente: assisto allo schiudersi del mio pensiero: Io osservo, Io ascolto: lancio una nota sull’archetto: la sinfonia fa il suo sommovimento in profondità, oppure d’un balzo è sulla scena. […] Se i vecchi imbecilli non avessero trovato, del “me stesso”, soltanto il significato falso, non avremmo da spazzar via i milioni di scheletri che, da tempo infinito, hanno accumulato i prodotti della loro orba intelligenza, e se ne proclamano gli autori!» Ne emerge l’immagine di una verità oscura e nascosta che non coincide con la luce della ragione (cfr. A. Rimbaud, Lettera a Paul Demeny, in Opere (a cura di D. Grange Fiori), Milano, Mondadori, 1975, pp. 450-459.
[25] Il Surrealismo realizza la diffrazione dell’identità con il costante richiamo al sogno, all’immaginario, all’irrazionale, all’automatismo, alla casualità. Potremmo rintracciare questa spinta alla dislocazione e alla scomposizione in tutte le correnti dell’avanguardia storica. Nel Cubismo è fin troppo evidente il programma di scomposizione della percezione, dello spazio, dell’identità. Nell’Espressionismo l’adozione di una poetica delle componenti oscure, magmatiche, evoca l’ulteriorità non riducibile del soggetto.
[26] R. Oliva, L’Io impossibile: la frantumazione… cit. p. 134.
[27] The Opposing Self, cit. in R. D. Laing, L’io diviso, Einaudi, Torino, 1991, p. 48.
[28] R. Oliva, L’Io impossibile: la frantumazione… cit. p. 131.
[29] Ivi, p. 136.
[30] R. Oliva, L’Io impossibile: la frantumazione… cit. pp.142-43.
[31] Ivi, p.144.
[32] Perniola ha parlato di “svolta fisiologica” intrapresa dalle arti e dalla estetica del Novecento, riferendosi a quel tipo di performance che si è proiettata verso la zona del “sentire”, che si attua e si rende visibile senza la mediazione preventiva della mente analitica e senza la “interpretazione” (precedente o posteriore) delle motivazioni che sono all’origine della azione. Il corpo non è stato più inteso come mezzo della manifestazione di una intenzionalità psicologica ed emotiva ma come luogo primario nel quale si realizza tale simultaneità, dunque un presente che coincide con il campo corporeo di esperienza vissuta, o in altri termini, con l’esclusività di un tempo in-corporato.
[33] L’assunzione pratica e teorica di tale questione ha reso necessaria una diversa lettura del rapporto tra emozione e sentire performativo proiettandola in una visione capace di spingere l’esperienza del performer oltre l’universo psicologico ed emotivo (personale, idiografico).
[34] M. Grande, La riscossa di Lucifero, Bulzoni Editore, Roma, 1985, cit. p. 55.
[35] Quella sorta di utopia umanistico-teatrale che ha alimentato tanti miti dell’uomo nuovo.
[36] La ricerca, avviata da molti riformatori, sulla densità dell’esperienza indipendente dalla mimesi, ha reso possibile la comprensione di quello che oggi definiamo il “sentire performativo”.
[37] F. Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1988, pp. 27-28.
[38] In U. Artioli, Poetiche teatrali del Novecento, in F. Cruciali e C. Falletti, Civiltà teatrale del XX secolo, Il Mulino, Bologna, 1986, cit. p. 48.
[39] Cfr. F. Marotti, La scena di Adolphe Appia, Cappelli Editore, Bologna, 1966.
[40] U. Artioli, Poetiche teatrali del Novecento, cit. pp. 54-55
[41] U. Artioli, Poetiche teatrali del Novecento, cit. pp. 50-51.
[42] G. Craig, Il mio teatro, (a cura di F. Marotti) Feltrinelli, Milano, 1971, cit. p. 29.
[43] G. Craig, Il mio teatro, cit. p 34.
[44] G. Craig, Il mio teatro, cit. p. 49.
[45] G. Craig, Il mio teatro, cit. p. 29.
[46] F. Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, cit. p. 107. Sulla strada della ricerca al di là del naturalismo troviamo la cifra della marionetta anche nei futuristi, potremmo ricordare le bambole meccaniche di Marinetti: «In Les poupées électriques, la marionetta è una bambola, robot al femminile, terreno vergine di sperimentazione dell’inconscio». F. Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, cit. p. 29. Ma soprattutto dobbiamo ricordare come i personaggi di Pirandello partecipino alla condizione dis-umanizzata di marionette, maschere (certo non come proposta liberatoria). Nei Sei personaggi troviamo tutti i termini della scissione che ha investito il nuovo soggetto del teatro: attore/personaggio, testo/esperienza, presente/passato, interno/esterno, coscienza/inconscio, identità/alterità. In Enrico IV, tragedia in un teatro di figure marionettistiche, la scissione dell’io è mantenuta come necessaria alla dialettica della identità.
[47] G. Craig, Il mio teatro, cit. p. 44.
[48] G. Craig, Il mio teatro, cit. p. 51.
[49] U. Artioli, Poetiche teatrali del Novecento, cit. p. 56
[50] Mejerchol’d, L’attore biomeccanico, Ubulibri, Milano, 1993, cit. p. 61.
[51] U. Artioli, Poetiche teatrali del Novecento, cit. p. 46.
[52] K. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, Laterza, Roma-Bari, 1988, cit. p. 231.
[53] K. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 353.
[54] Ivi, p. 22.
[55] K. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, cit. p. 228.
[56] U. Artioli, Poetiche teatrali del Novecento, cit. p. 47.
[57] Una chiara evidenza è il tentativo di Stanislavskij di sperimentare insieme a Mejerchol’d un tipo di recitazione “simbolista”, esperimento poi fallito.
[58] G. Guerrieri, Introduzione a K. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, cit. p. X. Sull’argomento cfr. anche M. Gordon, Il sistema di Stanislavskij, Marsilio, Venezia, 1992, p.111; e K. Stanislavskij, L’attore creativo, La Casa Usher, Firenze, 1989.
[59] K. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, cit. pp. 354-356.
[60] F. Cruciani, Alla ricerca di un attore non progettato, in F. Cruciani e C. Falletti, Civiltà teatrale del XX secolo, Il Mulino, Bologna, 1986, p. 86.
[61] F. Cruciani, Alla ricerca di un attore … cit. p. 93.
[62] In effetti la costruzione dell’uomo nuovo si sviluppa su due assi. Uno è quello sociale: il lavoro intorno alla cultura teatrale, volto a sostanziare il concetto di communitas, parallela e/o alternativa alla vita quotidiana. L’altro è quello più propriamente individuale: il lavoro volto a rifare il corpo-mente, attraverso i processi della improvvisazione.
[63] G. Scarpetta, Brecht o il soldato morto, Sugarco Edizioni, Milano, 1979, cit. pp. 72-73. Cfr. anche, pp.79-81.
[64] U. Artioli, Antonin Artaud e il Teatro della Crudeltà, in Il teatro di regia, Carocci, Roma, 2004, cit. p. 162.
[65] F. Ruffini, I teatri di Artaud, Il Mulino, Bologna, 1996, cit. p. 11.
[66] La teoria dell’atletismo affettivo, elaborata tra il ’35 e il 36, «consisteva fondamentalmente nell’individuazione del respiro (souffle) come l’unico strumento che può garantire la corrispondenza fra interno ed esterno dell’attore, cioè fra sentimenti ed espressioni, stati affettivi e stati fisici […] .Se il respiro rappresenta – secondo Artaud – lo strumento fondamentale per l’attore come “atleta del cuore”, questo accade perché per sua natura esso presiede all’organicità dell’essere umano, garantisce l’unità corpo-mente, azione-pensiero, gesto-emozione, materia-spirito; di conseguenza può diventare lo strumento principe per una ricostruzione dell’identità e della funzionalità psicofisiche laddove queste siano state duramente disarticolate» (M. De Marinis, La danza alla rovescia di Artaud, I Quaderni del Battelo Ebbro, Bologna, 1999, cit. pp. 61-63).
[67] In U. Artioli, Antonin Artaud e il Teatro della Crudeltà, cit. p. 157.
[68] U. Artioli, Antonin Artaud e il Teatro della Crudeltà, cit. p. 169.
[69] F. Ruffini (cfr. I teatri di Artaud) ha mostrato come Artaud cercherà di proiettare questa istanza “riparativa” in un primo momento nella figura del regista, poi attraverso i principi delle conoscenze tradizionali e/o misteriche e nell’ultima fase della sua vita, attraverso il rifacimento del corpo, la invenzione del corpo-tradizione.
[70] In M. De Marinis, La danza alla rovescia di Artaud, I Quaderni del Battelo Ebbro, Bologna, 1999, cit. p. 157.
[71] M. De Marinis, La danza alla rovescia …, cit. p. 159.
[72] In F. Ruffini, Per piacere. Itinerari intorno al valore del teatro, Bulzoni Editore, Roma, 2001, cit. p. 173.
[73] J. Grotowski, Per un teatro povero, Bulzoni Editore, Roma, 1970, cit. p. 149.
[74] In T. Richards, Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, Ubulibri, Milano, 1997, cit. p. 105.
[75] Una sorta di “ascolto” non selettivo, aperto a tutte le forme di polisemia. Cfr. R. Venturini, Coscienza e cambiamento, Cittadella Editrice, Assisi, 1995, p. 45.
[76] «Ogni esperienza, di portata trascurabile o eccezionale che sia, comincia con un impulso, anzi come un impulso. Dico “impulso” piuttosto che “stimolo”. Uno stimolo è speciale e particolare; anche quando è istintivo è semplicemente una parte del meccanismo impegnato in un più completo adattamento all’amnbiente. “Impulso” indica un movimento in fuori e in avanti di tutto l’organismo […]. Poiché è il movimento dell’organismo nella sua interezza, un impulso è lo stato iniziale di ogni esperienza completa» (J. Dewey, Arte come esperienza e altri scritti, La Nuova Italia, Firenze, 1995, cit. p. 69):
[77] W. Bion, Esperienze nei gruppi, Armando Editore, Roma, 1991, cit. , p. 111. Fra i processi elementari protomentali possono essere considerati il: trattenere/espellere, avvicinamento/allontanamento, salire/scendere, crescere/decrescere, prima/dopo. Processi che trovano uno sviluppo e una localizzazione nella pulsione (che pure, nell’accezione di Freud, è un fenomeno al di qua del fisico e del mentale).
[78] Non è stato sufficientemente indagato il legame tra pulsione e impulso. Non è nostra intenzione affrontare questo aspetto soltanto sottolineare la appartenenza al campo impersonale precategoriale.
[79] Il termine Trieb (pulsione) non è riducibile al nome di “istinto”, “pulsione” caratterizza in modo del tutto particolare la spinta, che è fuori dalla portata conoscitiva del soggetto. Più precisamente, per Lacan distingue la pulsione dalla funzione organica da essa abitata: la “zona esogena”. Lacan aggiunge alle note funzioni organiche o parti del corpo in cui la pulsione si installa, il fonema, lo sguardo, la voce, il rien (J. Lacan, Scritti, p. 821). Cfr. anche J. Lacan, Il seminario. Libro XI, Einaudi, Torino, 2003, pp.187-194. Cfr. J. A. Miller, La teoria del partner in “La Psicoanalisi”, n° 34, 2003, p. 55.
[80] Cfr. D. Stern, Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri, Torino, 1987. L’sperienza soggettiva globale e l’emozione come sintesi (p. 82.). Dalla percezione al sentimento estetico (p. 167).
[81] La filosofa Suzanne Langer ha insistito sulla necessità di porre attenzione a queste varie “forme del sentire” presenti in tutti i processi fondamentali della vita come respirare, avvertire fame, evacuare, addormentarsi, il trascorrere di pensieri, l’esplosione di un’emozione, la diluizione di un sentimento… Langer ha usato la nozione di “forme del sentire” per prendere in esame l’impatto emotivo di diverse forme artistiche (cfr. D. Stern, Il mondo interpersonale…, p. 69).
[82] Il filosofo J. Locke chiamò le proprietà come i colori, gli aromi, i gusti, le sensazioni, i suoni, qualità secondarie, per distinguerle dalle qualità primarie: dimensione, forma, movimento, numero e consistenza. Le qualità secondarie non erano di per sé “cose della mente”, ma piuttosto i “poteri delle cose” nel mondo (grazie alle loro qualità primarie) di produrre o provocare certe cose nelle menti. Successivamente i filosofi hanno adottato vari nomi per le cose o proprietà nell’osservatore per fornire un luogo, una dimora per le proprietà che la fisica ha espulso dal mondo “esterno” (colori, suoni, sensazioni varie, non si danno là fuori così come sono esperiti nella loro qualità di colore, suono ecc. ma solo in quanto onde, frequenze…). I nomi che sono stati inventati per albergare queste qualità espulse sono: “sensazioni grezze”, “percetti”, “qualità fenomeniche”, “proprietà intrinseche dell’esperienza cosciente”, “contenuto qualitativo degli stati mentali” e “qualia”. L’errore è stato di pensare a queste proprietà soggettive come a proprietà intrinseche speciali e addizionali, cioè proprietà che hanno una loro esistenza autonoma che si aggiunge alle qualità primarie.
[83] D. Stern, Il mondo interpersonale … cit. p. 162.
[84] Le emozioni vanno collocate rispetto alla posizione impersonale del soggetto, che anche per questo può essere affetto dalla sua stessa azione emotivizzante e diventarne così partecipe.
[85] In F. Ruffini, Per piacere. Itinerari intorno al valore del teatro, Bulzoni Editore, Roma, 2001, cit. p. 168
[86] Ivi, p. 175
[87] J. Grotowski, Per un teatro povero cit. p. 46.
[88] J. Grotowski, Per un teatro povero cit. p. 286. Cfr. anche p. 288.
[89] M. Heiddegger, L’abbandono, Il Melangolo, Genova, 1998, cit. p. 49.
[90] J. Grotowski, Tecniche originarie dell’attore, dispense a cura di L. Tinti, 1982-83, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dip. Di Musica e Spettacolo, Metodologia della critica dello spettacolo prof. F. Marotti, passim
[91] J. Grotowski, Per un teatro povero, cit. p. 48.
[92] T. Richards, Al lavoro con Grotowski…, cit. p. 132.
[93] Ibidem
[94] J. Grotowski, Per un teatro povero, cit. p. 302.
[95] J. Grotowski, Per un teatro povero, cit. p. 283.
[96] In F. Ruffini, Per piacere. Itinerari intorno al valore del teatro, Bulzoni Editore, Roma, 2001, cit. p. 186
[97] J. Grotowski, Per un teatro povero, cit. p. 240.
[98] Il debito del teatro alle tradizioni sapienziali, era già stato evidente prima di Grotowski, in Artaud (cfr. F. Ruffini, Artaud, Guénon, Barrault. Il “Grande teatro della tradizione”, in Teatro e Boxe, Il Mulino, Bologna, 1994; M. Baraldi, La Qabbalà e Antonin Artaud, in “Teatro e storia”, VI, n. 1, 1991; in Dalcroze, Decroux, Barrault, Coupeau, Dullin, attraverso l’euritmia di Steiner, o i movimenti e le danze sacre di Gurdjieff (B. Bonora, Lo spirituale nel corpo: Eliane Guyon da Decroux a Gurdjieff, “Culture Teatrali”, 1, autunno 1999; M. Gordon, I movimenti dimostrativi di Gurdjieff, “Sipario”, XXXV, n. 406, 1980; C. Sinibaldi, Il corpo spirituale. Sulle tracce della danza sacra contemporanea, “Teatro e Storia”, XII, n. 4, 1997); nell’Espressionismo (Berger, Fuchs) che si riferiva alle concezioni esoteriche del trimundio (cfr. U. Artioli, Poetiche teatrali del Novecento, in F. Cruciani e C. Falletti, Civiltà teatrale del XX secolo, Il Mulino, Bologna, 1986); in Ejzenstejn attraverso i riferimenti a I. di Loyola (S. Ejzenstejn, Il montaggio e l’attore, in F. Cruciani e C. Falletti, Civiltà teatrale del XX secolo, Il Mulino, Bologna, 1986).
[99] Nel quadro della liminalità il posto occupato dalla nozione più tradizionale di emozione (come contenitore in cui l’io può riversarsi e riconoscersi o da cui può allontanarsi), ha subito una dislocazione nel continuum performativo ed è stata racchiusa nella posizione/condizione del partecipante-testimone.
[100] Nel Buddhismo Mahayana la “via di mezzo” indica una posizione intermedia fra le dottrine dell’essere e del non-essere, considerate inutili in quanto la realtà assoluta non è né A né non-A né la negazione di entrambi. L’illuminazione consiste nel riconoscere che la nostra esistenza poggia su un fondamento vuoto. Vuoto di forme, di definizioni, di contenuti, di relazioni, di identificazioni. Le cose sono vuote, dal momento che non possiedono realtà indipendente e permanente. La consapevolezza del vuoto soggiacente all’esistenza fenomenica è la verità della “via di mezzo”.
[101] P. Violi, A Semiotica of Non-Ordinary Experience, “Versus” n. 83/84, Bompiani, Milano, 1999, cit. p. 248.
[102] Ci facciamo guidare dal saggio di P. Violi, che si colloca in quell’area della ricerca semiotica che ha cominciato ad investigare il campo pre-categoriale dell’esperienza e i suoi modi di espressione. A partire dalle nozioni di soggetto, oggetto, azione e stato, l’autrice cerca di costruire una leggibilità semiotico-linguistica dell’esperienza.
[103] Per Benveniste “attivo” denota un processo realizzato al di fuori del soggetto, che esprime esteriorità rispetto all’azione, mentre nella voce di mezzo, il processo ha luogo all’interno del soggetto, che è interno all’azione del verbo.
[104] P. Violi, A Semiotica of Non-Ordinary Experience, cit. p. 251.
[105] Ibidem
[106] P. Violi, A Semiotica of Non-Ordinary Experience, cit. p. 252.
[107] La liminalità, infatti, lascia il soggetto in una posizione di sospensione, di oscillazione e di concomitanza tra poli. Non a caso il modo per riconoscere e descrivere la liminalità, è stato quello degli stati di coscienza, la pluralità delle esperienze, la dualità, gli attraversamenti, la frattura spazio-temporale, l’extra-ordinario, tutte categorie del cosiddetto postmoderno. Il “soggetto di mezzo”, invece, è una affermazione di una diversa posizione che comprende l’io e le sue oscillazioni, non più sospeso, decostruito o alterato, ma trasformato nella sua stessa condizione.
[108] Alla luce di tale posizione è possibile comprendere li processo della “doppia incidenza” delle emozioni, in cui l’espressione ritorna come stimolo sullo stesso attore.
[109] C. Bene, Opere, Bompiani, Milano, 2002, cit. p. 3.
[110] «La teoria-prassi scenica artaudiana, dalla concezione dei testi all’esecuzione – addirittura coreografica – degli spettacoli fu un vero fallimento (Artaud rimane nella rappresentazione)» (C. Bene, Opere, Bompiani, Milano, 2002, cit. p. 4).
[111] C. Bene, Opere, Bompiani, Milano, 2002, cit. p. IX.
[112] «Mancanza non è un temporaneo venir meno dell’essere. È l’esistenza tutta un venir meno» (C. Bene, Opere, cit. p. 999)
[113] C. Bene e G. Deleuze, Sovrapposizioni, Quodlibet, Macerata, 2002, cit. p. 90.
[114] C. Bene e G. Deleuze, Sovrapposizioni, cit. p. 95; poco oltre precisa: «dunque eliminare tutto ciò che “fa” Potere, il potere di ciò che il teatro rappresenta (il Re, i Principi, i Padroni, il Sistema), ma anche il potere dello stesso teatro (il Testo, il Dialogo, l’Attore, il Regista, la Struttura)» (ivi, pp. 105-106).
[115] «Bene non è il primo a fare un teatro della non-rappresentazione. Si possono citare a caso Artaud, Bob Wilson, Grotowski, il Living…» (G. Deleuze, Sovrapposizioni, cit. p. 89).
[116] Il manque lacaniano non indica semplicemente la mancanza di (qualcuno, qualcosa, mancanza di essere o di avere), va piuttosto inteso come mancanza tra, non coincidenza. È l’azione originaria dell’Altro (dei sistemi simbolici, del linguaggio) a scavare una “mancanza” nel cuore dell’essere. «La mancanza del soggetto […] sorge come effetto di questa soggezione. Per questo Lacan può affermare che la divisione del soggetto è una divisione “costituente” e non costituita. Essa è costituente perché non si produce in un tempo secondo, supponendo uno stato mitico – una sorta di paradiso dell’identità – dove il soggetto poteva fare Uno. […] Non c’è affatto l’idea dell’Uno che, in un tempo secondo, diventa Due. […] All’origine non c’è né l’Uno, né il Due ma un non-Uno, un non-tutto, una divisione appunto come effetto sul soggetto dell’azione dell’Altro. È il significante infatti che “intacca” il soggetto producendolo come soggetto diviso» (A. Di Ciaccia e M. Recalcati, Jaques Lacan, Bruno Mondadori, Milano, 2000, cit. pp. 62-63).
[117] C. Bene, Opere, cit. p. 999.
[118] Come abbiamo sottolineato nel § 1, la distinzione tra io e soggetto è cruciale nella teoria lacaniana: l’io si presenta come una riduzione, una alienazione del soggetto.
[119] L’Altro, indicato con la a maiuscola, non è per Lacan l’altro dell’intersoggettività, ma è l’ordine del simbolico, le leggi della cultura e del linguaggio, che preesistono al soggetto stesso, lo avvolgono e lo determinano. È il discorso dell’Altro (familiare, storico, sociale). L’Altro è il luogo dei significanti, luogo della parola come materia primaria. «Il luogo dell’Altro si configura come una rete che avvolge in una sincronia fondamentale l’essere del soggetto ancora prima della sua nascita. In una sincronia fondamentale perché il campo del linguaggio precede l’essere dell’uomo e lo determina. […] Il linguaggio non è dunque un mero strumento della comunicazione ma è un campo, una rete, una struttura che determina il soggetto. È questo il carattere ‘primordiale’ che Lacan attribuisce all’Altro» (A. Di Ciaccia e M. Recalcati, Jaques Lacan, cit. p. 45).
[120] M. Grande, in C. Bene, Opere, cit. pp. 993-94.
[121] C. Bene, Opere, cit. p. 997.
[122] M. Grande, La riscossa di Lucifero, Bulzoni Editore, Roma, 1985, cit. p. 172.
[123] P. Giacchè, Carmelo, dopo, in AA. VV., A Carmelo Bene, Editoria & Spettacolo, Roma, 2003, cit. p. 142.
[124] Il soggetto è, per Lacan, diviso per effetto del linguaggio (ovvero, dell’Altro): «per effetto di parola, il soggetto si realizza sempre più nell’Altro, ma a questo punto non persegue già più che una metà di sé stesso. Troverà il suo desiderio solo sempre più diviso, polverizzato nella metonimia circoscrivibile della parola […]; il soggetto non è soggetto che per il fatto di essere assoggettamento al campo dell’Altro, il soggetto proviene dal suo assoggettamento sincronico in questo campo dell’Altro. Per questo motivo è necessario che egli ne esca fuori, che se ne esca fuori e, nel venirne fuori, alla fine, saprà che l’Altro reale deve, tanto quanto lui, venirne fuori, sbrogliarsela» (J. Lacan, Il seminario. Libro XI, Einaudi, Torino, 2003, cit. p. 183). Se riuscirà a “venirne fuori”, da soggetto diviso diverrà un “soggetto di mezzo” (che non vuol dire giocare la rappresentazione ma semmai trascinarsi dietro l’Altro, il linguaggio, la forma). Da Io diviso a soggetto diviso (cioè non-io, rifiuto dell’istanza di identità) a soggetto di mezzo.
[125] “La coscienza, la presa di coscienza è una grande potenza, ma non è fatta per le soluzioni, e nemmeno per le interpretazioni. Quando la coscienza ha abbandonato le soluzioni e le interpretazioni, allora essa conquista la propria luce, i propri gesti e suoni, la propria decisiva trasformazione” (Deleuze, 112-113).
[126] U. Volli, Prefazione, in C. Bene, Nostra signora dei turchi, Sugarco Edizioni, Milano, 1978, cit. p. 13.
[127] M. Grande, La riscossa … cit. p. 59.
[128] M. Grande, La riscossa … cit. p. 63.
[129] S. Colomba, La voce come consolazione metafisica del misfatto teatrale, ovvero: un orecchio di più, in C. Bene, La voce di Narciso, Il Saggiatore, Milano, 1982, cit. p. 82.
[130] G. Luporini, Un ricordo per Carmelo, in AA. VV., A Carmelo Bene, Editoria & Spettacolo, Roma, 2003, cit. p. 54.
[131] C. Bene, Opere, cit. p. 639.
[132] C. Bene, Opere, cit. p.1167.
[133] C. Bene e G. Deleuze, Sovrapposizioni, Quodlibet, Macerata, 2002, cit. p. 102.
[134] C. Bene e G. Deleuze, Sovrapposizioni, cit. p. 122.
[135] S. Colomba, La voce come consolazione metafisica…, cit. p. 84.
[136] C. Bene, Opere, cit. p. 1015. La voce che “si ascolta dire”, e torna come eco sull’attore stesso. Nella macchina attoriale la phoné funziona “retroattivamente” come una sorta di ritorno, di eco che viene da fuori e lo “commuove”; l’attore è in balia della sua stessa eco, «commosso dal suo stesso canto, fuori dal senso» (C. Bene, Opere, cit. p. 1021).
[137] M. Grande, La riscossa…, cit. p. 67.
[138] C. Bene, Opere, cit. p. VI.
[139] Vedi la nota 79 al § 3.1.
[140] Esiste una lunga tradizione di pensiero «che si è occupata dei rapporti fra la voce e il soggetto, fra la voce e la coscienza così come si manifesta nella “soggettività verbale”: fra la voce e l’avvento dell’essere nel linguaggio, ma anche fra la voce e la presenza della morte come esperienza primaria del linguaggio. Una riflessione che ha còlto la “necessità” della voce come capacità di evocare la non-esistenza della “cosa” nella cancellazione del suo esistere immediato operata dal trasferimento nel nome, nella “idealità” del sostituto simbolico. È questa la facoltà umana di far pervenire le “cose” a quel non-esistere che è il linguaggio; dove si attesta l’“illusione simbolica” che rimpiazza l’irripetibilità dell’esistente nella “permanenza” del linguaggio (secondo il tracciato hegeliano che descrive il passaggio dalla “intuizione sensibile” alla memoria, e dalla memoria al linguaggio. Memoria come ricordo di sé e come liquidazione dell’essere empirico delle cose nella “idealità” del nome)» (M. Grande, La riscossa… p. 183). Lacan ha dato una spiegazione al legame voce-morte in quanto la voce-phoné come pulsione, fa entrare nel soggetto il senso della morte, restaura in lui la sua perdita originale (J. Lacan, Scritti, p. 852; J. Lacan, Il seminario. Libro XI, p. 172).
[141] M. Grande, La riscossa…, cit. p. 63.
[142] J. Lacan, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud (1953.1954), Einaudi, Torino, 1978, cit. p. 86.
[143] J. Lacan, Il seminario. Libro I …, cit. p. 283. Sull’argomento cfr. anche G. Bottiroli, Lacan. Arte, linguaggio, desiderio, Bergamo University Press, Edizioni Sestante, Bergamo, 2002.
[144] Cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro XVII, Einaudi, Torino, 2001.
[145] C. Bene, Opere, cit. p. XXX.
[146] C. Dumoulié, Omaggio a Carmelo Bene, “poeta increato del soffio”, in in AA. VV., A Carmelo Bene, Editoria & Spettacolo, Roma, 2003, cit. p. 16.
[147] J. Lacan, Il seminario. Libro XI…, cit. p. 178.
[148] J. Lacan, Dio e il godimento de La donna, “La Psicoanalisi”, n. 34, 2003, cit. p. 21.
[149] E. Fadini, annunciandolo come sorprendente e micidiale, tenta un paragone tra Grotowski e Bene, concludendo che «Grotowski è un terapeuta, C.B. un uccisore: il teatro di C.B. è delittuoso, quello di Grotowski pretende la santità e promette beatitudini» (in C. Bene, Opere, cit. p. 1541)
